Modulo 26 – Esercizio #2

Ho già stigmatizzato questa idiozia, e ora è il momento di demolirla definitivamente, perché è fondamentale smazzar via ogni dubbio, fare massima chiarezza in fatto di educazione alla scrittura e realizzazione di un testo.
Chi è uno scrittore? È un signore che ha in testa una storia – tecnicamente, un arco di trasformazione del personaggio – e possiede quanto meno le conoscenze di base per rappresentarla al meglio nel mondo della pagina.
Chi è un formatore? È un signore che possiede le conoscenze per realizzare una storia e per rappresentarla nel mondo della pagina – e spesso le possiede a un livello superiore allo scrittore – ma non ha in testa una storia da scrivere.
E ora dimmi: in che modo non avere in testa una storia toglie valore alle conoscenze teoriche?
Sarebbe censurabile se il formatore tenesse un atteggiamento di non-collaborazione – quasi di disdegno verso lo scrittore – perché dispiaciuto nel vedere un corpo perfetto di teoria doversi adattare a una storia specifica che non potrà mai essere altrettanto adamantina.
Così come sarebbe stigmatizzabile se il formatore avesse un atteggiamento pseudo-collaborativo, di distacco verso lo scrittore, a cui trasferisce sì conoscenza, senza però accettare il dialogo e il confronto sul testo sotto esame.
Ma un vero formatore tiene sempre un atteggiamento di autentica collaborazione, che influenza il suo stesso percorso mentale: il formatore non si limita a fornire soluzioni già pronte; affronta piuttosto il problema insieme allo scrittore, e lo studia affinché i vincoli della teoria inducano a sprigionare le soluzioni migliori in quella specifica storia.
La stupidaggine del chi sa fare fa, chi non sa fare insegna si regge sull’equivoco intorno al significato del verbo fare.
Per realizzare una buona storia (nel mondo della pagina) bisogna fare molte cose, e la cosiddetta “divisione del lavoro” non è certo una delle tante novità tecnologiche dei giorni nostri. La sosteneva l’economista Adam Smith, nel ’700, e alcuni la fanno risalire addirittura a Menenio Agrippa, intorno al 494 avanti Cristo. Dividiamoci il lavoro, affinché ognuno possa fare quel che sa fare meglio, nella prospettiva di raggiungere l’esito migliore per tutti. Dividere il lavoro non raddoppia i risultati e non dimezza i rischi: decuplica i primi e decima i secondi.
Puoi vederla nei termini del Principe e del suo Consigliere: il Principe (lo scrittore) ha la testa troppo affollata di pensieri (di storie, o di possibili sviluppi di una sola storia) per vederne nitidamente ogni singolo risvolto (ogni aspetto della teoria), che solo il suo Consigliere (il formatore) può prospettargli con la necessaria chiarezza (riportandolo sempre alle scelte migliori) proprio perché la sua testa è sgombra di pensieri (di storie) e riesce pertanto a ragionare in modo più preciso (maggiormente conforme alla teoria).
Quindi – per favore, per cortesia – piantala con questa idiozia del chi sa fare fa, chi non sa fare insegna, smettila di palesare la tua imbecillità domandando a un formatore di scrittura di mostrarti ciò che ha scritto, visto che ha la pretesa di insegnare. Meglio tacere, e dare l’impressione di essere idioti, che parlare e togliere ogni dubbio, non trovi?
Coloro che scrivono e insegnano – ne parlavo nel modulo 14 – lo fanno perché obbligati a farlo: perché – al netto di una frazione irrisoria, stimata nello stesso ordine del numero dei vescovi italiani – nessuno vive di scrittura, nessuno paga mutuo, bollette e assicurazione auto con i proventi delle vendite dei propri libri; ci si deve arrangiare, se si è scelto di lavorare in editoria, anche perché pecunia non olet, e le cosiddette royalties incrementano il conto-corrente allo stesso modo dei pagamenti ricevuti per altri servizi (100 euro rimangono 100 euro, poco importa se provengono dalla vendita di 50 libri o dalla prestazione di 1 ora di consulenza).
Ma ora – per quel minimo che vorrai riflettere – capirai che è imprenditorialmente rischioso assommare su di sé entrambe le figure, dello scrittore e del formatore.
Se insegno scrittura e al tempo stesso scrivo romanzi, se alterno il mio tempo tra un’attività e l’altra, ci sarà il rischio che un mio studente, dopo aver letto una mia storia, possa mettermi di fronte alla più imbarazzante delle verità: “caro formatore di scrittura, in base ai tuoi meravigliosi insegnamenti su come si progetta una storia e la si mette sulla pagina, io posso sicuramente dire che il tuo romanzo, l’opera che tu, formatore, hai realizzato, è una montagna di merda”.
Le ragioni – di un testo di merda, pur scritto da chi conosce le regole della buona scrittura – sono riassunte modulo introduttivo agli esercizi e in ultima istanza, se vogliamo, si riconducono alla pigrizia, sempre in agguato quando si scrive.
Come si fa a proteggersi dal rischio di una figura di merda?
Semplice: si alterano i principî dell’insegnamento sino a snaturarli, si dilata il perimetro delle soluzioni ammissibili fino a includervi praticamente ogni possibile scelta, si suggerisce di fare una cosa, ma si afferma che pure il suo contrario va bene, e si arriva a dire che la scrittura non si insegna ma si può imparare (sic!) perché in fondo – notiziona! – non è mica una scienza esatta, e ognuno deve trovare la sua strada da sé, “la sua voce” come si dic con grande stile; si dice e si fa tutto questo, e tante altro ancora, e però si vuol far intendere che la scrittura sia una disciplina seria, un’arte, un’attività che richiede impegno e dedizione.
Con questo trucchetto si tengono due piedi in una scarpa, si ha la botte piena e la moglie ubriaca – e perdonami i cliché, ma non ho voglia di trovare immagini migliori, a testimonianza di quanto sia infida la pigrizia – si può insomma dire che il proprio testo, per quanto scritto male, sia conforme agli insegnamenti che si impartiscono, artatamente alterati rispetto agli standard più rigorosi, proprio per poter giustificare praticamente ogni cosa.


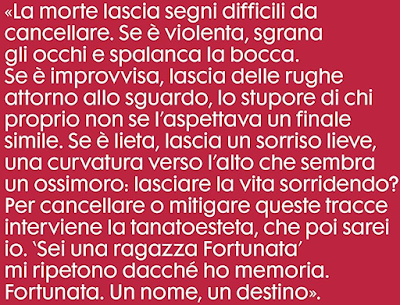





Problema oggettivo: la nostra protagonista sognava di fare la pasticcera, lavora invece per un’impresa funebre, e “per caso” fa l’investigatrice. È scritto proprio così, in copertina: “Fa la truccatrice in un’impresa funebre. E l’investigatrice per caso”. Per caso? Fa l’investigatrice per caso? Ma – santo cielo! – cos’è che abbiamo ripetuto sino allo sfinimento? Che le storie ci piacciano, ci affascinano, ci coinvolgono, ci lasciano qualcosa dentro perché il caso – la (s)fortuna, l’imprevedibile – ha un ruolo del tutto marginale, puramente accessorio. Non sarà mai possibile eliminare del tutto gli elementi di casualità da una storia – non sarebbe neppure desiderabile: si avrebbe una narrazione meccanica e straniante – ma non è il caso a determinare il corso degli eventi, che devono sempre essere percepiti interconnessi, collegati da nessi di causa-effetto. Dare rilevanza al caso, nel presentare la propria storia, è sempre un autogoal, perché un lettore tiepido si irrigidisce.
Interazione tra questione soggettiva e problema oggettivo: se la protagonista è una “investigatrice per caso”, com’è possibile che riesca a sbrogliare le situazioni in cui si ritrova? Cioè, la protagonista non ha nessuna competenza specifica nelle indagini (in fondo voleva fare la pasticcera, e di fatto trucca i defunti) e però – c’è da scommetterci – viene a capo di misteri che i professionisti delle indagini (polizia, carabinieri, investigatori privati) sono incapaci di concludere con successo. Proprio come Don Tonino. E allora, forse, sono legittimato a pensare che il libro non valga tanto di più di quella serie anni ’80.
.jpg)
.jpg)
«Fortunata?»
Chiudo gli occhi e mi mordo il labbro: questo è il colonnello Braghin…
Le azioni compiute dal “Punto di Vista” (chiudere gli occhi e mordersi il labbro) comunicano di per sé apprensione e il pensiero successivo (“è la voce del colonnello Braghin…”) non solo ci fa capire, nel sotto-testo, che il “Punto di Vista” sta dando le spalle al personaggio che ha parlato (perché ne ha riconosciuto solo la voce, quindi non l’ha visto) ma soprattutto ci informa sull’identità di quel personaggio (il colonnello Braghin) che di per sé mette curiosità e fa stare in apprensione (è un colonnello, cavolo!).
Fatto. E se ci si ragionasse un po’ di più, rispetto ai cinque secondi che vi ho dedicato io, si potrebbero trovare soluzioni sicuramente migliori. Ma, appunto, serve ragionare.
.jpg)
.jpg)
Stessa storia per “sento tutti gli sguardi puntare su di noi”. Non è meglio – infinitamente meglio, o più semplicemente corretto – “tutti gli sguardi puntano su di noi”, e va da sé, nel sotto-testo, che è una sensazione psicologica, perché è ovvio che la protagonista non può effettivamente vedere gli sguardi di tutti, e tuttavia se li sente addosso (uno stato d’animo che possiamo ben comprendere, senza bisogno di “sento”).
.jpg)
Stati d’animo dichiarati. Cosa abbiamo detto nel modulo 10? Che gli stati d’animo del “Punto di Vista” non si dichiarano mai esplicitamente, ma si trasmettono, indirettamente, tramite un’opportuna sequenza dei cinque mattoncini narrativi.
.jpg)
Avverbi di tempo. Cosa abbiamo detto nel modulo 15B? Che gli avverbi di tempo (i “mentre”, i “quando”, i “prima”, i “poi”, …) sono vietati nel mattoncino delle percezioni sensoriali, perché creano connessioni temporali che tradiscono lo Show, don’t tell.
.jpg)
Il punto rimane: il gerundio non è un tuo amico, non è amico degli scrittori.
E guarda qua, infatti: “Sospiro e chiudo gli occhi, abbassando lo straccio con cui stavo asciugando le tazzine”.
Ma quante cosa stanno accadendo, simultaneamente? Il tempo necessario a sospirare e chiudere gli occhi è fose lo stesso tempo necessario ad abbassare lo straccio? E ti sei accorto, poi, che quel “con cui stavo asciugando” viola lo Show don’tell?
.jpg)
E chi è – poi – questo “Signor M.”? E perché la protagonista lo percepisce come “Signor M.” e non con il suo nome? Lei, la protagonista, lo sa, perché il “Punto di Vista” sa tutto e capisce sempre tutto, per definizione (a meno di casi di ironia drammatica). Ma il lettore cosa capisce? Nulla. E allora vuol dire che il lettore è stato di nuovo sbalzato fuori dal “Punto di Vista”.
E guarda che sto appena accentuando gli errori, in questi miei controesempi, solo affinché tu li possa vedere meglio; ma la loro natura è la stessa degli errori commessi dall’autrice: pensieri e percezioni che il “Punto di Vista” non avrebbe mai, data la situazione in cui si trova, e che stanno lì solo per informare il lettore. In una parola: infodump.
E che dire di tutto il blocco che inizia con “Che poi il bar sia collocato in un quartiere molto popolare” e finisce con “il rifugio perfetto per una ragazza che aveva un unico desiderio: sparire”? Roba che ammazzerebbe un toro, altroché.
.jpg)
Poeti mancati. Tutta la “poesia” che si decide di inserire in un testo di narrativa deve sempre essere tutta e solo espressione delle cosiddette percezioni psicologiche del personaggio “Punto di Vista”.
.jpg)
Lo so cosa stai per rispondermi: continua a leggere e lo saprai, l’autrice l’ha fatto apposta a tenerti all’oscuro delle cose, proprio per invogliarti a proseguire nella lettura.
Bravo genio! Lo so benissimo come funziona il gioco, ho letto anch’io Scienza dello storytelling di Will Storr, e ho ben chiaro che il cervello è incuriosito dal mistero, per cui formula le sue congetture e poi gode nel verificarne l’esattezza; e quindi, sì, bisogna mantenere il lettore sulle spine per invogliarlo a proseguire nella lettura.
Ma non è così che si fa.
Non è davvero ammissibile arrivare sino a questo punto, e non avere ancora cristallina la situazione narrativa in cui ci si trova.
Questa è la realtà dei fatti: 151 recensioni, con una media di 4,1 stelle su 5, e una distribuzione statistica che dà conto di quasi metà dei lettori (il 47%) pienamente soddisfatti e di una minoranza comunque significativa (il 10%, in totale) fortemente scontenta.
E a noi, qui, interessa proprio il parere di questa frangia di insoddisfatti.
Intendiamoci: anche il miglior testo immaginabile ed effettivamente realizzato avrà la sua quota di 1 e 2 stelle, per un banale discorso di “grandi numeri”; sempre si troverà una frangia di insoddisfatti, perché la statistica non perdona, perché il 100% non esiste; non si può quindi pensare di screditare un libro semplicemente puntando i riflettori sulle recensioni negative, perché il giochino è banale, e – come ogni banalità – insignificante.
Ma qui il punto è un altro: noi vogliamo analizzare le recensioni negative perché solo la frangia di insoddisfatti può fornire spunti di miglioramento; non sempre una recensione negativa ci sarà d’aiuto, ma tutto ciò può esserci d’aiuto si trova sicuramente dentro una recensione negativa; non saranno certo le orgasmatiche recensioni a 4 e 5 stelle a dirti dove puoi migliorare, non trovi?
Okay, d’accordo, magari qualcuno ha recensito con 1 stella perché il libro gli è arrivato in ritardo ed era pure danneggiato; o perché il nome della protagonista gli ricordava una sua ex che l’aveva cornificato con tutti i suoi amici; o perché… vabbè, hai capito che non ci sono limiti ai motivi per cui la tua opera può dar luogo a mal di pancia e borbottii, e del resto tu non puoi pensare di inseguire il consenso universale, perché, appunto il 100% non esiste, né in scrittura né altrove, e gran parte delle nostre cosiddette “verità”, al di fuori delle scienze esatte, sono solo regolarità statistiche.
Okay, d’accordo, ma forse – dico forse – qualche recensione negativa potrebbe avere qualcosa di interessante da dire.

Questi non sembrano – proprio no – gli sfoghi di chi ha trovato la moglie a letto con un altro, e ora se la prende col tuo romanzo perché non sa cos’altro fare.
Da queste recensioni – forse – c’è qualcosa da imparare.
Grazia Santacroce ha sicuramente acquistato il libro (“acquisto verificato”) e con ogni probabilità lo avrà anche letto; e auspica che “prima di scriverne un altro, l’autrice faccia dei corsi di scrittura” (sic!). Ora, di là di tutto, è o no lo stesso pensiero che abbiamo avuto noi, qui sul blog, dopo aver esaminato le prime pagine?
Da ciò che scrive “Cliente A” (“Amo le storie di questo tipo, ambientate nella provincia italiana”) dobbiamo presumere di trovarci di fronte a un lettore caldo, ben predisposto verso il soggetto in sé, e quindi benevolo verso tutto il resto. Il prezzo dell’e-book (€ 10,99) l’ha tuttavia messo sulla difensiva, e qui ci sarebbe da aprire tutto un discorso sul pricing dei libri, interessante in sé, che però potrebbe a divagare. Teniamo la barra dritta: “leggo con cura l’estratto per ben due volte e valuto se ne vale la pena. No, non ne vale la pena, per me”. E non è forse la nostra stessa valutazione, qui sul blog, per tutti le ragioni spiegate, tra cui – toh! – l’utente pizzica tre gerundi in una riga e mezza?
“A” è stato incuriosito da un titolo (morire ti fa bella) che scimmiotta un film celebre (La morte ti fa bella) e qui ci sarebbe da ricordare che il primo che disse “fresca come una rosa” fu un genio, il secondo un cretino. Ancora una volta l’anteprima gratuita ha frenato l’acquisto, anche perché, di nuovo, “il prezzo per un tipo di scrittura così scadente è fuori dal mondo”, e si stigmatizzano in particolare “gli aggettivi ridondanti” che “danno un senso di infantile al racconto”.
Sono tutte osservazioni che sembrano pescate dai moduli del blog, e riproposte con linguaggio più immediato e diretto; e sono critiche che dovrebbero far riflettere, se non proprio l’autrice (che si sarà già creata per altre via un pubblico caldo) quanto meno te, lettore del blog, che ambisci a scrivere al meglio e a dare il meglio di cui sei capace.
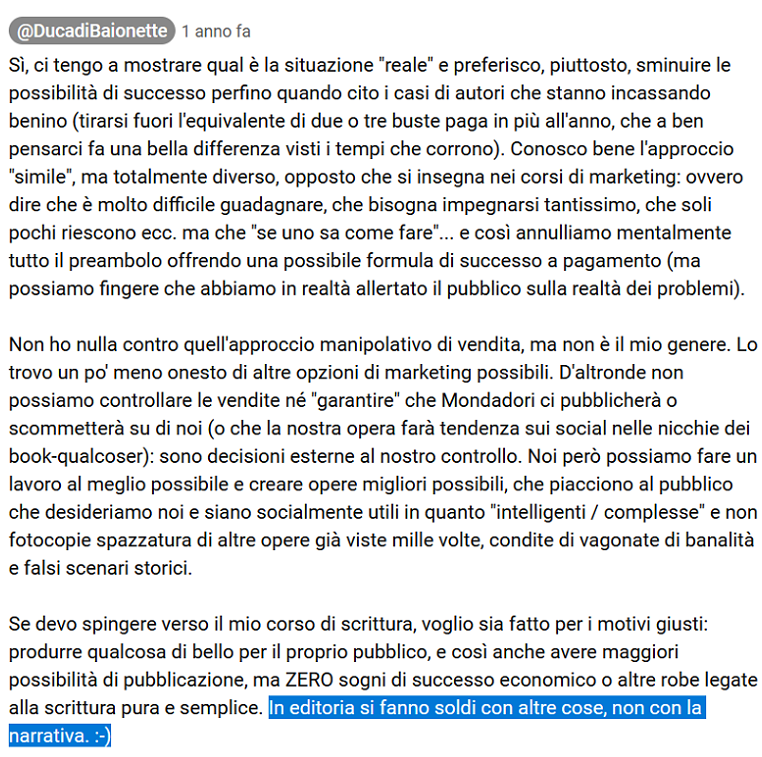






Commenti
Posta un commento