Modulo 26 – Esercizio #1
Le parole di Marcello Veneziani andrebbero stampate su un foglio da attaccare allo specchio del bagno, per richiamarle alla memoria tutte le mattine, e ogni volta che ci si guarda in faccia.
Muoviamo da un dato di fatto: gli scrittori sono diventati un multiplo dei lettori, l’offerta (di romanzi) sovrasta la domanda (di lettura) e, sì, bisogna credersi onnipotenti per pensare di aver creato un’opera speciale, unica, realmente diversa dalle altre 84.999 che ogni anno – ogni anno! – invadono il mercato (nel 2000 erano “solo” 20.000, per darti un’idea di quanto sia dilagata la smania di scrivere). Un terno al lotto avrebbe probabilità decisamente migliori – 1 su 11.748 – ma credendosi Dio, appunto, a quell’unica probabilità viene conferito il potere di fagocitare le altre 84.999 concorrenti.

Against the gods, against the odds: il mio romanzo (autobiografico) sarà un successo, anche se non ho mai studiato scrittura, anche se sono un esordiente.

Su questo libro, al momento, abbiamo solo tre informazioni: il nome dell’autrice (Adriana Giotti, una esordiente), il titolo (La linfa sale dalle radici), la copertina (un albero inclinato sulla sinistra, col mare sullo sfondo) e la casa editrice (Scatole Parlanti, che non è un editore a pagamento).
Non si può dire nulla sul contenuto del libro, sin qui. Bisognerebbe leggerlo, si dirà. Ma siamo sicuri che serve leggerlo per darne un giudizio, o almeno per farsene un’idea?
Procediamo con ordine.
Questo libro si presenta al pubblico come un romanzo, e voglio allora richiamare alla tua attenzione – con le parole di Will Storr – la caratterizzazione tecnica di un romanzo, ciò che il lettore si aspetta di trovare dentro un’opera qualificata come romanzo:
È chiaro che tipi di storie differenti avranno un diverso grado di enfasi e complessità psicologica, ma alla fine una trama senza personaggio sarebbe soltanto una giostra di luci e suoni. Il senso viene a crearsi soltanto quando l’imprevisto giusto va a toccare la persona giusta al momento giusto”.
“… i protagonisti della storia non sono in guerra soltanto con il mondo esterno. Ma anche con sé stessi. Devono affrontare battaglie che avranno luogo soprattutto nei sotterranei oscuri del loro subconscio. In gioco c’è la risposta all’interrogativo cruciale di ogni dramma: chi sono io?
Chi è questa persona? Ecco l’interrogativo che tutte le storie ci pongono. Emerge contestualmente al punto di innesco. Quando il cambiamento iniziale lo colpisce, il protagonista reagirà in modo eccessivo o darà comunque prova di un comportamento insolito. Saltiamo su, improvvisamente più attenti. Chi è questa persona che si sta comportando così? L’interrogativo tornerà a porsi tutte le volte che il protagonista verrà messo in discussione e sarà costretto a compiere una scelta.
Dovunque, nella trama, si porrà tale interrogativo, il lettore o lo spettatore si sentiranno coinvolti. Quando questo dilemma non si presenta, e gli eventi procedono al di fuori del suo fascio di luce narrativo rischieranno di provocare un senso di distacco, o persino di noia.
Sono parole così chiare, precise, sintetiche ed esaustive, che ad aggiungere altro – a volerle commentare o chiosare – si rischierebbe di rovinarle.
E ora – con le parole di Will Storr nello specchietto retrovisore – vediamo come il libro La linfa sale dalle radici viene presentato dalla stessa casa editrice che lo ha pubblicato.
Quel che hai appena letto è il cosiddetto pitch: una descrizione sintetica dell’opera, che dovrebbe invogliare ad acquistarla e leggerla (l’equivalente di un teaser per un qualsiasi altro prodotto commerciale, perché, sì, incredibile a dirsi, ma i libri sono dei “prodotti da portare sul mercato”, con l’obiettivo di venderne il più possibile).
E ora fermati un attimo, prima di leggere le mie osservazioni.
Cosa noti di strano in questo pitch?

La Sicilia del dopoguerra, in ritardo sul processo di ricostruzione post-bellica dopo essere stata relegata ai margini del miracolo economico italiano, e il popolo siciliano, la cui fierezza ha trasformato miriadi di dominazioni e invasioni in lingua, usi e tradizioni unici al mondo: sono loro i veri protagonisti delle pagine di questo romanzo.
Cosa sono le frasi in rosso? Non lo sai? Te lo dico io. Sono degli incisi.
E cos’è un inciso? È una frase che ne spezza un’altra.
Spezziamo una frase quando vogliamo attirare l’attenzione su un messaggio particolare, pertinente al discorso generale, ma esterno all’ordinario flusso comunicativo: l’inciso è cioè un modo per enfatizzare un messaggio (spezziamo il flusso, per dare risalto a quel che ci sta in mezzo).
Nel caso volesse rinnovare il contratto – soluzione che auspichiamo – le ricordiamo che dovrà farci pervenire conferma a mezzo raccomandata entro 15 giorni e provvedere al contestuale invio di una e-mail all’indirizzo segreteria.societaria@affitti.com.
Quel “soluzione che auspichiamo” ha messo in pausa il flusso informativo sulle azioni necessarie per rinnovare il contratto, per comunicare l’auspicio che la controparte lo rinnovi: la trasmissione di un’informazione puramente tecnica (sulle modalità di rinnovo del contratto) è stata interrotta per comunicare uno stato d’animo (l’auspicio di rinnovo).
È chiaro qual è l’uso corretto dell’inciso? Una frase (breve) che ne spezza un’altra, allo scopo di attirare l’attenzione su di sé, nell’ovvio presupposto che sia una frase meritoria di attenzione.
Qual è invece l’uso distorto dell’inciso? Una frase (spesso lunga a piacere) che ne spezza un’altra, al solo scopo (privo di senso) di inzeppare quante più informazioni possibili in un unico periodo testuale.
Diffida per principio di chi sbaglia a usare gli incisi: è un segnale inequivocabile di scarsa presa sul linguaggio scritto, e se non si ha presa sullo strumento che si usa, cosa mai si potrà produrre?
.png)
Okay, d’accordo, lanciamo il cuore oltre l’ostacolo dell’inciso e andiamo alla sostanza del pitch, che riscrivo in forma abbreviata e asciutta (senza incisi) per coglierne il messaggio con chiarezza.
La Sicilia del dopoguerra e il popolo siciliano: sono loro i veri protagonisti delle pagine di questo romanzo.
Cosa? La Sicilia del dopoguerra e il popolo siciliano? Sono loro “i veri protagonisti” del romanzo?
Ma come fanno “la Sicilia del dopoguerra” e “il popolo siciliano” a essere i protagonisti di un romanzo?
Cosa dice Will Storr?
“… vogliamo scoprire come quella particolare persona, con quella particolare storia, e con quei punti di forza e quei punti deboli riuscirà a cavarsela”.
Di questo parla un romanzo: di quella particolare persona, con quella particolare storia, con quei particolari punti di forza e debolezza. E come si raccordano tutte queste particolarità – questo essere una persona precisa, con una storia precisa, in una situazione precisa – con “la Sicilia del dopoguerra” e “il popolo siciliano”, che sono entità generiche e astratte?
Se vuoi parlare dell’umanità, parla di un singolo uomo è un precetto basilare della narrativa. Le storie – ripetiamolo – parlano di “come quella particolare persona, con quella particolare storia, e con quei punti di forza e quei punti deboli riuscirà a cavarsela”. E chi è, qui, che dovrebbe riuscire a cavarsela? La Sicilia in tutta la sua interezza, tutto il suo popolo, nessuno escluso?
Pazienza, se l’autrice ignora bellamente i prerequisiti necessari per dire di aver scritto un romanzo. Ma la casa editrice – santo cielo! – dovrebbe conoscerli, non ti pare? È il suo lavoro, accidenti! E invece no. Anche la casa editrice – a quanto pare – sembra all’oscuro delle basi della narrativa.
Ma si può sapere, esattamente, cos’è questo libro e come si pensa di venderlo? O perché si crede che qualcuno dovrebbe comprarlo?
.png)
L’idea di scrivere una storia traendola dal proprio vissuto – di travasare le proprie esperienze reali sulla pagina, per trasformare la propria vita in un romanzo – si colloca in un filone letterario classico, che torna periodicamente di moda: l’autobiografia.
Qual è il problema?
Semplice: o hai un vissuto straordinariamente interessante, oppure scriverai qualcosa di cui non fregherà niente a nessuno.
Banale, vero? Forse lo è, ma sai qual è il problema? Che se non sei un professionista della scrittura, se non hai precise conoscenze narratologiche, non sarai mai in grado di capire quali eventi della tua vita siano davvero interessanti e quali no, perché tutto ti apparirà straordinario, eccezionale, unico, e quindi meritorio di essere raccontato.
E tutto ti apparirà così – straordinario, eccezionale, unico – per il semplice fatto che è la tua vita, che quelle esperienze le hai vissute tu, nel mondo reale, sulla tua pelle. Sono tutte cose che ti hanno segnato nel profondo, e viste in retrospettiva ti fanno sentire il protagonista di un libro che si dipana automaticamente sotto i tuoi occhi: il libro, il romanzo, della tua vita.
Qual è il problema? Che questo romanzo meraviglioso – il libro della tua vita – al momento ha per lettori soltanto te e la tua cerchia.
Quel che invece tu vuoi fare – che dovresti voler fare – è trasformare gli eventi della tua vita in una narrazione capace di avvincere chiunque, senza illuderti che il responso dei lettori caldi (che colorano e ravvivano le tue pagine con la conoscenza diretta che hanno di te) sia una buona proxy della risposta dei lettori tiepidi o freddi (che non ti conoscono, non fanno sconti, e per i quali rileva solo ciò che si trova scritto sulla pagina).
Rimane una frattura tra lettori caldi e lettori tiepidi, che può sanarsi solo con la conoscenza delle tecniche di scrittura e sceneggiatura. Altrimenti – con imperdonabile faciloneria – finirai con lo snocciolare sulla pagina delle interminabili sequenze di fatti che saranno pure bellissimi per te, ma risulteranno incredibilmente urticanti per il lettore. Sempre ammesso che qualcuno sia arrivato ad acquistarlo il tuo libro, che il tuo pitch, anziché incoraggiarlo, non l’abbia dissuaso dall’aprire il portafoglio.

Consacra come un postulato questa elementare verità: il 99% degli esseri umani sono persone normali, con vite normali, anche se il 99% degli esseri umani, guardandosi indietro, ritiene di aver vissuto esperienze straordinarie.
E – al solito – ti prego di non farmi dire quel che non dico, semplicemente ripetendo le mie parole.
.png)
A 17 anni provai ad aggredire fisicamente il mio professore di informatica. Ci volle l’impressionante forza di Padre Papotto, l’insegnante di religione (non invento nulla: si chiamava proprio così, Padre Papotto, ed aveva una forza mostruosa) per bloccarmi e impedirmi di mettergli le mani addosso.
Ricordo il sorriso tenero di mia madre, l’anno successivo, dopo la maturità (strappata con 40/60): “tu non sei quello che dicono tutti, tu sei in gamba, e io ho fiducia in te… perché non provi con l’università, puoi farcela, io lo so…”.
Ma va là! Stiamo scherzando? Mi risuonavano ancora nelle orecchie le parole del professore di Fisica: “Ascolta a me: tu libri non ne mangi, lo studio non fa per te, non sei proprio cosa. Sai qual è l’unica cosa che puoi fare nella vita? Prendere un bel mitra, un bel passamontagna e… tarataratan… andare a rapinare le banche!”, con tanto di mimica – braccia piegate e pollice e indice distesi a richiamare una pistola – per simulare una smitragliata.
Ma quale università, per favore! Il mio primo colloquio di lavoro – a 18 anni – fu per un’impresa di pulizie di condomini. Volevo fare questo nella vita: lavare scale e pianerottoli. Erano pur sempre soldi, no?
“Io ho fiducia in te…”. Il sorriso di mia madre si faceva ogni giorno più dolce. “Prova ad andar via da qui. Ti piacerebbe studiare a Roma?”
Cazzo, se mi piaceva l’idea di Roma: significava poter andare allo stadio ogni volta che la Roma giocava in casa! Bisognava però trovare una facoltà che fosse soltanto a Roma, e da nessun altra parte, così da rendere presentabile la scelta anche a mio padre.
Dopo una ricerca piuttosto complessa – era il 1992, internet non esisteva – atterai su un corso di laurea dal nome criptico: Scienze Statistiche Attuariali. Fino a “Scienze Statistiche” ci arrivavo. Cosa volesse dire “Attuariali” non ne avevo idea. Ma non importava. Tutto ciò che contava è che – all’epoca – queste “Scienze Statistiche Attuariali”, qualunque cosa significassero, stavano solo a Roma e Trieste.
Fatto! Che Scienze Statistiche Attuariali sia. Da Sant’Agata Li Battiati – paesino del catanese, con nemmeno diecimila anime – a Roma, la capitale: wow!
I primi mesi romani furono meravigliosi: ogni giorno era una Disneyland, un carnevale di Rio, e tutto a spese di mamma, s’intende, perché “tu devi pensare solo a studiare, di tutto il resto mi occupo io” (e mamma, per inciso, era un assistente sociale, non un’ereditiera).
Fino al giorno del primo esame: compito scritto di Analisi Matematica I. Mi siedo al banco, leggo il testo, sospiro e scuoto la testa: mi alzo e riconsegno il foglio bianco, senza neppure provare a svolgere gli esercizi. Per poi regolarmi col classico strumento dello studente fuori sede, per acquietare i genitori: la bugia.
Dissi a mia madre – al telefono – che l’esame era parecchio impegnativo, che preferivo provarlo alla seconda sessione, piuttosto che alla prima, perché altrimenti avrei rischiato una figuraccia.
Potevo vedere il suo sorriso, senza averlo sotto gli occhi. “Certo, fai bene: sono sicura che andrà benissimo”.
Misi gù la cornetta – all’epoca non esistevano i cellulari – e scoppiai a piangere, tra lo sgomento dei ragazzi con cui condividevo l’appartamento.
La seconda sessione d’esame si aprì con una dichiarazione di guerra, da parte di uno degli assistenti del professore: “Sono accaduti fatti piuttosto sgradevoli durante la prima sessione, che non siamo disposti a tollerare una seconda volta. Perciò, sia chiaro: se per qualsiasi ragione, anche ingiustificata, dovessimo avere anche solo la vaga sensazione che qualcuno sta copiando, provvederemo a ritirare i compiti all’istante, e non accetteremo repliche o giustificazioni”.
Erano le tre del pomeriggio di un qualche giorno di inizio febbraio, e un sole pallido illuminava appena il mio banco. Calai la testa sul foglio e quando la rialzai era tutto buio intorno. Avevo riversato in quel compito tutto me stesso, e se possibile anche di più. Non restava che aspettare il verdetto.
L’esame funzionava così: se superavi lo scritto, potevi evitare la prova orale, nel senso che il professore – il più delle volte – ti offriva la verbalizzazione del voto dello scritto, esonerandoti dall’interrogazione; sostenere l’orale era una libera scelta della studente, finalizzata ad alzare il voto, ma era una scelta sgradita al professore, un po’ perché lo annoiava dover organizzare un’ulteriore sessione d’esame, un po’ perché la interpretava come una manifestazione di superbia da parte dello studente; quei pochi che c’avevano provato – che si erano avventurati oltre le colonne d’Ercole del voto positivo dello scritto – erano stati un monito per tutti gli altri, della serie “colpirne 2 per educarne 20” (a uno era stato confermato il voto dello scritto, e quindi aveva faticato invano, e l’altro… era stato bocciato!).
Questa era la regola, la norma. Ma poi – di quando in quando – c’erano le eccezioni. Compiti scritti che erano sì fatti bene, ma non così bene da giustificare il superamento dell’esame senza un’interrogazione orale. Eccezionalmente, cioè, era il professore stesso a imporre la prova orale a quegli studenti con una preparazione percepita borderline. Io ero un un’eccezione, un borderline.
C’erano quattro eccezioni da valutare, in quel pomeriggio freddo e cupo di fine febbraio, e funzionava così: ti chiamavano alla cattedra e ti interrogavano, professore e assistenti; poi ti facevano allontanare e confabulavano tra loro per una ventina di secondi; e poi i casi erano due; o scuotevano la testa, per dirti che non era andata, che eri stato bocciato, oppure facevano segno di avvicinarti, per comunicarti il voto, che a quel punto non poteva che essere positivo.
Va la prima eccezione: interrogazione, allontanamento, confabulazione, teste scosse.
Va la seconda eccezione: interrogazione, allontanamento, confabulazione, teste scosse.
Va la terza eccezione: interrogazione, allontanamento, confabulazione, teste scosse.
Arriva il momento della quarta eccezione, il mio momento.
La prima domanda è sulle serie numeriche; le serie non le avevo studiate granché, ma conoscevo bene le successioni (che sono alla base delle costruzione delle serie) e così tenni botta come potevo; ma le smorfie sulle loro facce non lasciavano sperare nulla di buono.
La seconda domanda non la ricordo, ma – qualunque fosse e qualunque cosa abbia risposto – ricordo che le smorfie del professore e degli assistenti si erano fatte più cattive.
La terza domanda rimane indimenticabile: “La funzione y=x2 è suriettiva, iniettiva, o biiettiva?”.
Rimasi in silenzio un paio di secondi.
L’assistente mi incalzò. “Quindi?”.
Abbozzai un sorriso. “Sto solo aspettando che lei completi la domanda”, e Dio solo sa dove trovai la forza per una replica così sfrontata.
Si scambiò uno sguardo con l’altro assistente e col professore, a metà tra il deluso e il compiaciuto, due stati d’animo contrapposti, ma originati dallo stesso fatto: la sua era una domanda-trabocchetto e io – cazzo, vaffanculo – nel suo trabocchetto non c’ero cascato.
Il professore, con un gesto della mano, mi invitò a spiegarmi meglio.
“Una funzione è definita da una legge e da un dominio. Voi mi avete dato solo la legge, y=x2, ma non il dominio, non mi avete detto in quale insieme varia la x, e quindi non posso rispondere. Perché se il dominio è quello ‘formalmente ammissibile’ – cioè l’intero asse reale – allora è una cosa; ma se il dominio, per dire, fosse limitato ai reali positivi, allora la cosa cambierebbe del tutto”.
Spiegai con gran dettaglio i diversi casi, e da quella domanda specifica ritornai poi alla logica generale, senza che nessuno – professore o assistenti – mi avesse chiesto nulla.
Sospirarono all’unisono, e mi dissero di allontanarmi.
Forse parlottarono per i soliti venti secondi, o forse no, non so dirlo; di sicuro, per me, ogni secondo si dilatò all’infinito; mi sembrava di vivere una sospensione spazio-temporale.
“Ventuno” fu l’unica parola dell’assistente.
Annuii, per confermare che il voto mi andava bene, e si procedette alla verbalizzazione.
Il ragazzino che a 17 anni aveva provato ad aggredire un professore, e si era salvato solo grazie alla raccomandazione dello zio, ora aveva superato il suo primo esame universitario, Analisi Matematica I, in una sessione che sino a quel momento era stata una strage (molti anni dopo venni a sapere che quando mio zio lo aveva raccontato alla professoressa di matematica della scuola – “sai, mio nipote ha superato l’esame di Analisi I all’università” – la sua replica era stata un inno allo scetticismo: “non ci credo, non ci crederò mai, neppure se vedo il libretto”).
Presi le mie cose e iniziai a correre verso casa (abitavo a via dei Mille, vicino l’università). Correvo veloce e sempre più veloce, in preda allo sconvolgimento interiore di chi sente che sta attraversando uno stargate, per entrare in un nuovo mondo.
Afferrai il telefono, composi il numero, e…
Quel giorno – il giorno del mio primo esame universitario – è senza discussioni uno dei cinque giorni più belli di tutta la mia vita, e sicuramente è il giorno più importante in assoluto: è il giorno in cui tutto è cambiato, il giorno in cui ho capito che, no, non era vero che io libri non ne mangiavo, il giorno in cui ho realizzato che potevo fare qualcosa di più, di meglio, che indossare un passamontagna e imbracciare un mitra per rapinare le banche.
Alzai il ritmo, e di molto, e iniziai a macinare un esame dopo l’altro; in alcuni frangenti arrivai a studiare oltre dieci ore al giorno, per parecchi mesi di fila, a dare fino a 8 esami in un anno, senza trucchi, senza mezzucci, senza scorciatoie, ma solo con un duro lavoro sistematico. Non andò sempre tutto liscio, ovvio. A volte (poche) giravo a vuoto, le cose non andavano come volevo, ma non aveva nessuna importanza. Perché ormai possedevo la mentalità giusta, quella che – per dirlo con Renato Zero – ♫più la combatterai, più si difenderà, non sai tu questa gente quante risorse ha!♬.
Un pomeriggio di inizio marzo, davanti alla bacheca degli orari delle lezioni, notai la presenza di un bando di concorso: “BANCA D’ITALIA – 60 ASSUNZIONI DI LAUREATI CON ORIENTAMENTO ECONOMICO STATISTICO”.
Un mese dopo, per Pasqua, mia madre venne a trovarmi. Nella mia stanza, seduti sul letto, le raccontavo come procedevano le cose.
“Sai, mamma, credo di sapere cosa voglio fare dopo l’università: lavorare in Banca d’Italia. Mi sono già informato, il concorso esce tutti gli anni, sempre più o meno verso settembre. Sì, io lavorerò in Banca d’Italia”.
Mi abbracciò e sul viso le si dipinse un sorriso che non le avevo mai visto, e che forse covava da sempre dentro di sé. “Non sai quanto sono felice…”.
Da quel momento iniziò la mia scalata a Palazzo Kock, supportato da una squadra – per dirlo col rapper J-Ax – ♫in cui ancora gioco e credo, che mi ha allenato, mi ha cresciuto, mi ha difeso, e in cambio non ha mai preteso niente, gente che per anni ha dato, ha atteso, e in cambio nulla ha preso♬.
Non è stato facile. Proprio no. Ci sono stati momenti esaltanti e altri deprimenti. Attimi in cui tutto sembrava possibile, e periodi in cui sentivo il peso delle piume. Ci sono stati sorrisi e lacrime, speranze e delusioni, giorni di burrasca e altri senza vento. C’è stato tutto e il suo contrario, e tutto quel che successo – per dirlo ancora con J-Ax – ♫fu per arrivare te♬.
Già. Proprio così. Più o meno.
.png)
Perché, sai, io ho lacrimato tutto il tempo, nel ripercorrere questo tratto della mia vita, e tutta la gente intorno me, in questo bistrot in cui abitualmente scrivo, mi guardava come fossi uno scemo.
E forse anche tu hai avuto la stessa sensazione, nel sentirmi dire che il giorno del mio primo esame universitario è stato il più importante di tutta la mia vita, e tra i cinque più belli in assoluto. Tutta questa enfasi per un esame universitario? Che esagerazione! E che sarà mai? È solo un esame!
Già. Ma per me che l’ho vissuto è invece meraviglioso. Perché è capitato a me, che ho una mia specifica storia alle spalle, che solo io e la mia cerchia conosciamo in tutti i suoi più minuti dettagli, e che ci porta a percepire quel giorno – il giorno del primo esame – come pazzesco, esaltante, straordinario. Ma per tutti gli altri, sì, è solo uno stupido esame universitario, come se ne tengono di continuo in ogni parte del mondo.
Cosa ci insegna Pontiggia?
Che scrivere non è trascrivere quel che si è pensato o vissuto, ma scoprire sulla pagina quel che non si sapeva di pensare o di aver vissuto: scrivere è pensare con la penna, perché la testa sa poco di ciò che la mano scrive, e deve scoprire quel che la penna vuol dire.
Il romanzo indimenticabile è quello che ti fa scoprire e riconoscere qualcosa che stava dentro di te e non sapevi di avere, qualcosa che evoca valori universali attraverso specifici eventi personali.

del tuo “disagio diffuso” non frega niente a nessuno,
e se la tua scrittura diventa lo specchio di una cosa a cui non frega niente a nessuno,
cosa pensi che possa accadere a ciò che scrivi?
Dopodiché – chiaro – puoi sempre fondare l’ennesima rivista on-line, autoproclamartene redattrice,
Dopodiché, sì, in tutte queste specificità riecheggiano temi generali, di ampio respiro, sulle contraddizioni del Risorgimento e sulla natura dei siciliani, che offrono spunti di notevole interesse per capire meglio un pezzo di storia nazionale mai abbastanza studiato, nonché l’indole di un popolo tra i più caratteristici al mondo: “l’incoerente adattamento al nuovo, ma nel contempo l’incapacità vera di modificare sé stessi, e quindi l’orgoglio innato dei siciliani” – nella sintesi di Wikipedia – è un messaggio che aleggia sull’intera storia, che si desume dalla storia, ma che non si potrebbe mai usare come pitch della storia (di sicuro non oggi, anno 2024).
Se invece si prende in mano un libro di narrativa, lo giro per leggere la quarta di copertina, e anziché un pitch accattivante, ci si vede prospetta un’analisi socio-economico-antropologica della Sicilia e dei siciliani, beh, scusa tanto, ma il libro con ogni probabilità lo si lascerà dove sta, perché alla fine si voleva semplicemente leggere un romanzo, e non sorbirsi una pseudo lectio magistralis di una professoressa improvvisata.
.png)
Questo e l’incipit del libro La linfa sale dalle radici, reso pubblicamente disponibile dell’autrice, sul suo profilo Facebook.
Il troncone di via s’innesta in un viale di cipressi secolari che svettano oltre i tetti e abbuiano le casupole basse di uno dei rioni più poveri della città, dove la miseria serpeggia ignara di vie di fuga o sedotta da insidiose scorciatoie. In quei dedali disordinati e impenetrabili restano i segni del caos postbellico, e di un tentativo fallito di ricostruzione e ripresa economica dell’isola.
Cinquant’anni fa, la mia famiglia viveva in quel moncone di via, miracolosamente risparmiato dai bombardamenti dal ’40 al ’43, che avevano devastato la zona circostante. Tra la gente si era diffusa la voce che il vicolo avesse un santo protettore particolare, forse persino più potente della ‘santuzza’. Forse per questa ragione o, più plausibilmente, per preservare i figli dalla fame che la guerra aveva lasciato come prova del suo passaggio, nonno Alfredo aveva acquistato un’intera palazzina del vicolo.
Dentro il vicolo la povertà non trovava via d’uscita e s’accaniva contro i miserabili intrappolati in quel budello di mondo.
L’ho già precisato nel modulo di apertura, e lo ripeto adesso: non ha senso fare line editing su un testo concepito senza l’obbedienza a un set condiviso di principî e regole (e in questo caso, a dirla tutta, non si sa bene neppure con la quale tecnica, ammesso ve ne sia una).
Va bene tutto, d’accordo. Ma almeno la coerenza – l’ormai celeberrimo find the logic di Ilenia Zodiaco – si potrà pretendere o no?
Leggiamo di “uno dei rioni più poveri della città, dove la miseria serpeggia”, di una “povertà [che] non trovava via d’uscita e s’accaniva contro i miserabili”, e poi però veniamo a sapere che “nonno Alfredo aveva acquistato un’intera palazzina del vicolo”.
Un’intera palazzina, per l’amor del cielo! Ma come si concilia l’acquisto di un’intera palazzina – non una casa o due, no: un’intera palazzina – con la necessità di “preservare i figli dalla fame”?
Sulle strade che odorano di sangue e sconfitta, siamo costretti a scegliere ogni giorno di restare dove l’onestà rischia di diventare una colpa.
Gli eroi pagano per i vivi mai per i morti.
Sulla tomba di un eroe piangiamo la perdita, ma impariamo a diventare tedofori dei valori e dei principi che sono il segno, l’emblema dell’onore. Sulla tomba di “mezzi omini” e “ominicchi” non c’è nulla da piangere né da imparare, tranne che, per chi grufola nel fango, la vita e la morte sono parte della stessa inesorabile sconfitta.

Se “42” è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, sull’universo e tutto il resto – nella serie di romanzi di fantascienza umoristica Guida galattica per gli autostoppisti, di Douglas Adams – la costante universale per la totalità degli autoproclamati scrittori è invece “50”. Cinquanta libri: questa è la soglia invalicabile, per le copie vendute da chiunque abbia velleità letterarie, per chi coltiva ambizioni senza coltivare i mezzi per realizzarle.
Possibile? Sì, possibile, anzi è proprio così: la stragrande maggioranza dei libri – e pressoché la totalità dei libri degli esordienti – non supera le 50 copie vendute (per gran parte, se non tutte, all’interno della cerchia dei lettori caldi).
Su YouTube trovi almeno tre video – due correlati, il terzo indipendente – che ti spiegheranno in dettaglio l’intero meccanismo, se la cosa proprio ti interessa.
Quindi, fai la cortesia: smettila di prendertela con l’editore, di dare la colpa all’editore per ciò che succede a te, autore; perché l’editore ha già i suoi diavoli a cui dar conto, e non può mettersi appresso alle lagne di chi si crede un Pirandello redivivo solo perché alle scuole medie i suoi temi facevano venire i lucciconi alla professoressa di italiano.
Nell’immaginario collettivo c’è lo scrittore da un lato, con la sua arte, il suo talento, il suo genio, che si manifestano nel libro finito; e poi c’è l’editore dall’altro, con la sua conoscenza del mercato, le sue abilità di marketing, i suoi canali distributivi, che garantiscono la massima diffusione della creazione letteraria dello scrittore. A ognuno il suo compito, ognuno si occupi di ciò che sa fare: io – autore, artista – creo quell’entità pura e nobile che è il libro, e tu – editore – ti occupi dello sporco commercio.
Non so dire, sinceramente, se sia mai esistita una fase in cui vi fosse davvero una contrapposizione di compiti così netta, ma oggi – anno 2024 – di sicuro non funziona più così (ammesso, ripeto, che abbia mai funzionato così in un trapassato remoto).
per cui gli autori sono i fornitori sia della materia prima, il libro,
sia i fornitori di clienti”


L’editore, oggi, semplicemente “ti presta il suo nome” e mette a disposizione il suo circuito di vendita; ma poi – sottinteso, ovvio – sei tu, autore, che devi promuovere il tuo libro, preoccuparti di farlo conoscere, in una parola di venderlo; sei totalmente fuori strada se pensi che l’editore abbia a disposizione un pubblico già bell’è pronto a cui rifilare il tuo romanzo; il pubblico – notiziona! – devi portarglielo tu.
E a questo punto, probabilmente, ti si starà formando in testa un pensiero preciso.
Ma se sono io a dover scrivere il libro, a dover trovare il pubblico, e infine a convincerlo ad acquistare, si può sapere a cosa mi serve l’editore?
Esatto, bravo!
La tecnologia ha reso possibile il cosiddetto self-publishing, per cui un autore può (deve) diventare imprenditore di sé stesso, costruendosi un eco-sistema di riferimento entro cui collocare le proprie opere, come accennato a conclusione del modulo 21C.
Questa è la normalità, oggi, ed è questo new normal che serve avere in testa se si vogliono fare due metri di strada in questo mondo, anche quando c’è un editore di mezzo, e anche se si tratta di un grande editore.
Le repliche migliori le sono arrivate proprio dai suoi amici su Facebook, non da tutti, ovviamente, ma da alcuni sì, e sono argomentazioni perfette in sé e molto ben formulate.




Basterebbe riflettere un minimo su questo insieme di osservazioni – relativamente facili da interiorizzare, provenendo da da persone amiche, verso cui si presume una spiccata propensione all’ascolto – per rimettere tutto nella giusta prospettiva, imparare dall’esperienza, e ripartire con un nuovo sogno.


Ma sì, certo, continuiamo pure a urlare contro il soffitto: vedrete quante belle soddisfazioni ci toglieremo con la scrittura!
Non sminuire i lettori – che sono pur sempre un pubblico da conquistare, blandire e coccolare – solo perché di quando in quando vogliono svagarsi in una vita che ha già le sue pesantezze, e nella quale – non lo dimenticare – vi sono oggi tante altre fonti di svago alternative a un buon libro, tutte realizzate da figure molto più preparate e competenti dei cosiddetti, sedicenti, “scrittori”.
Piuttosto, ribalta il tavolo a tuo favore: avvicina il lettore con quel che il lettore vuole – una storia con cui svagarsi – ma poi abbi cura di trasmettergli un messaggio forte, chiaro, duraturo – attraverso l’arco di trasformazione del tuo protagonista – affinché quel momento di svago si riveli sì “una fonte di crescita, di arricchimento, di conoscenza”, ma nel modo corretto, coerente con lo scopo e le tecnica dell’arte narrativa (persuadere di una tesi attraverso le emozioni provate immedesimandosi nella vita di un altro).

E allora leggiamolo qualche stralcio – reso pubblico – di questo saggio “sui talenti, vera motrice del pensiero” – che sta nel cassetto da oltre un ventennio.
Gli uomini ti “rivelano” e ti “sigillano” a loro piacimento, come se Tu non avessi più niente da dire o noi non dovessimo cercarti fuori dai recinti delle religioni che ti contendono come se Tu fossi un trofeo. Proclamano la tua onnipresenza, ma negano che sei in ogni Credo e creatura. Proclamano la tua onniveggenza, ma accecano la ragione e oscurano la verità con sigilli, dogmi, canoni e decreti. Proclamano la tua onnipotenza, ma ti destituiscono, manipolano le tue parole e i tuoi verbi, rinnegano i tuoi insegnamenti, millantano l’infallibilità, trasformano le creature in carnefici e militi di crociate e guerre sante.
Tu non sei morto, anzi, noi abbiamo più che mai bisogno di Te. Perché quando le nostre colpe diventano insostenibili, quando smettiamo di usare i nostri talenti, sei Tu la vittima sacrificale. È a Te che imputiamo le nostre guerre, i nostri campi di sterminio, i nostri olocausti, la siccità e le inondazioni, i disgelamenti e le desertificazioni, i cancri e i virus, i conati del mondo che sembra stanco di ospiti voraci, indiscreti e insolenti.
Ma io so che avanzo a fatica sotto il fragile riparo della conoscenza, e lascio sia la ragione l’egida delle mie convinzioni. Preferisco le mie pavide e infedeli certezze al tuo bieco e sanguinario culto. Preferisco i miei dubbi all’esaltazione che tu chiami fede, preferisco i miei martellanti “perché” alle tue esanimi risposte.
Nessuno potrà mai convincermi che, al respiro affannoso e roco di chi lo cerca, Dio preferisca i cori e le litanie di miliardi di servi obbedienti che ne soffocano la voce.
Non tento la scalata all’infinito con la zavorra dei dogmi e dei veti, dei deliri e delle visioni. Non accetto di perdermi negli abissi del fanatismo, del dogmatismo e del proibizionismo spirituale.
Il mio Credo accoglie le verità semplici che sfuggono alle anime contorte e ai miserabili, e mi pongo davanti alla realtà senza la pretesa di sapere e senza la paura di non sapere.
E così hai spaccato il mondo in due emisferi incompatibili: quello in cui ti abbandoni all'insolenza e al cinismo dei vincitori che credono di non avere più bisogno di provare la propria grandezza morale, spirituale e intellettuale; e quello in cui rinneghi i talenti.
E così, se da un lato pretendi di esercitare un potere assoluto anche sulle cose che non hai creato e di stabilire un ordine che privilegia i risultati ai meriti; dall’altro, ti pieghi a culti e pregiudizi atavici, e ti stordisci con echi desertici che destituiscono la ragione e ti allontanano dalla verità.
Hai creato due emisferi incompatibili su cui erigi altari sconsacrati per sacrificare le prerogative che ti hanno permesso di pensare, creare, sognare e amare come la creatura più simile a un dio.
“Se vogliamo addestrarci all’uso consapevole ed efficace delle parole, se vogliamo capire e usare meglio la nostra facoltà di parlare, se vogliamo intenderne tutta la straordinaria importanza nella nostra vita privata e pubblica, dobbiamo almeno per un momento fermarci a riflettere su questo punto.
Se esprimere sé stessi è un’attività libera e auto-referenziale, comunicare è invece una tecnica precisa, da studiare e applicare, per affinarla di continuo.
Chi non ha voglia di studiare e di applicare ciò che ha studiato, chi si pratica da sé degli sconti rispetto alla tecnica, chi pensa che non accada nulla a trasgredire le regole della comunicazione, potrà ancora esprimere sé stesso, sicuramente, ma non dovrà poi meravigliarsi se la più parte del pubblico preferirà leggere una ricetta di cucina o guardare foto di animali carini, che – nella loro futilità – mantengono il pregio di comunicarsi agli altri con la massima chiarezza.

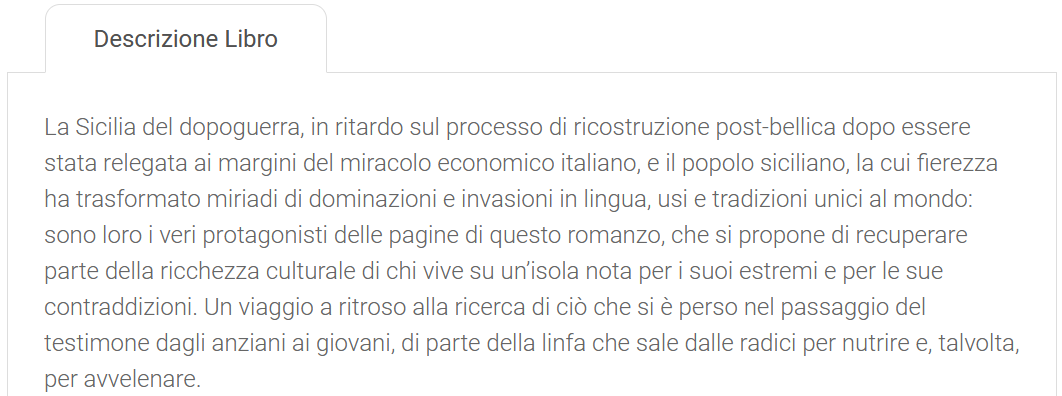



















Commenti
Posta un commento