MODULO 6 – Fragilità e potenzialità del mondo della pagina

Il mondo della pagina è reale, vero, concreto, come lo è il mondo
in cui viviamo noi, ed è popolato da esseri reali, veri, concreti, come lo siamo noi.
Ma il mondo della pagina è anche drammaticamente fragile, di sicuro molto più del nostro: se è servito un asteroide per far estinguere i dinosauri sulla Terra, un alito di vento può bastare a per stropicciare, accartocciare o bucare la pagina.
La fragilità della pagina è il riflesso della debolezza intrinseca allo strumento che la crea, la scrittura, la forma espressiva più lasca in assoluto, per una ragione precisa: non coinvolge nessuno dei cinque sensi.
Noi usiamo quasi sempre la facoltà sensoriale più potente (la vista) e spesso anche la seconda più rilevante (l’udito) per entrare in contatto con l’arte: al cinema e al teatro le cose si vedono e si sentono; nei fumetti, nella fotografia e nella pittura si vedono; nella musica e negli audio-libri si sentono; e fermami pure, quando pensi di aver afferrato il concetto.
Noi entriamo in contatto con l’arte attraverso le due percezioni sensoriali più importanti – la vista e l’udito – ma in scrittura non si vede e non si sente niente. O meglio: in scrittura si vedono solo parole scritte su una pagina, semplici segni grafici che il cervello dovrà poi tradurre in immagini, suoni, odori, colori, sapori, e da qui in stati d’animo e sensazioni. La scrittura – a differenza di tutte le altre forme d’arte – non comunica direttamente con lo spettatore, ma indirettamente, per evocazioni.
Noi usiamo quasi sempre la facoltà sensoriale più potente (la vista) e spesso anche la seconda più rilevante (l’udito) per entrare in contatto con l’arte: al cinema e al teatro le cose si vedono e si sentono; nei fumetti, nella fotografia e nella pittura si vedono; nella musica e negli audio-libri si sentono; e fermami pure, quando pensi di aver afferrato il concetto.
Noi entriamo in contatto con l’arte attraverso le due percezioni sensoriali più importanti – la vista e l’udito – ma in scrittura non si vede e non si sente niente. O meglio: in scrittura si vedono solo parole scritte su una pagina, semplici segni grafici che il cervello dovrà poi tradurre in immagini, suoni, odori, colori, sapori, e da qui in stati d’animo e sensazioni. La scrittura – a differenza di tutte le altre forme d’arte – non comunica direttamente con lo spettatore, ma indirettamente, per evocazioni.
Evocare ciò che si trova sulla pagina, e integrarlo con ciò che sulla pagina non sta scritto ma è suggerito dal contesto; poter partecipare all’opera dal di dentro, senza subirla dall’esterno come avviene al cinema; convocare la nostra immaginazione per dare corpo, anima e respiro alla storia, è ciò che ci fa amare la narrativa scritta, e specularmente ci spinge a scrivere narrativa, per portare gli altri all’interno del nostro mondo, per renderli partecipi della vita dei nostri personaggi, così da consegnargli un messaggio che risuoni col loro animo.
Ma questa potenzialità della scrittura – che peraltro bisogna imparare a governare, per non dissiparla – non è altro che l’altra faccia della sua fragilità.
Tu cosa vedi?
La moglie o la suocera,
la giovane o la vecchia?
Se non le vedi entrambe,
potresti avere un problema:
ti accorgi della potenzialità della scrittura,
senza capire che è il contraltare della sua fragilità.
La pagina – ficcatelo in testa! – è un mondo fragile, per l’assenza di un vincolo percettivo forte (in termini di vista e udito) tra il lettore e l’opera.
Prendiamo per confronto il podcast, giusto per dare un primo esempio in cui tanti possono rivedersi.
Ti infili le cuffie, e già così ti isoli dal mondo (il tuo udito è votato all’ascolto della voce che ti parla nelle orecchie, le distrazioni esterne, se non azzerate, di sicuro sono limitate); ma al tempo stesso puoi restare in contatto col mondo, perché la fruizione dell’opera non ti limita nelle tue attività (puoi ascoltarlo durante una passeggiata, in palestra, mentre fai le pulizie, e persino quando stai aiutando tua figlia a fare i compiti).
Puoi aver scelto quel podcast perché dedicato a un argomento di tuo specifico interesse – ad esempio il Medioevo – oppure solo per il suo autore – in quanti dicono che ascolterebbero Alessandro Barbero anche se annunciasse gli orari dei treni? – e nel migliore dei casi perché c’è la combo, con Barbero che ti parla di Medioevo.
Qualunque sia la situazione, ce ne vuole per buttarti fuori dal tuo bel podcast!
Ma in scrittura non c’è nulla di tutto questo.
Quando leggi, anzitutto, non puoi far altro. Devi stare fermo e leggere, concentrato sulla pagina, il che è senz’altro limitante, stancante, e può diventare fastidioso. Pure, a meno che tu non abbia un interesse enorme verso ciò che stai leggendo – e qui abbiamo escluso questa eventualità, qui abbiamo in testa i lettori tiepidi – basta un niente a farti distogliere
l’attenzione e abbandonare il libro: l’abbaiare
del cane del vicino, lo scampanellio di un messaggio WhatsApp, il
rumore della lavastoviglie o della lavatrice, il pensiero alla riunione
di lavoro di domani, la curiosità di consultare la mail, il bisogno di un giro sui social, e Dio solo sa che altro.
Non devo certo
spiegarti che viviamo in un’epoca in cui i deficit di attenzione sono la normalità, a causa del bombardamento di stimoli esterni di ogni tipo, vero?
Anche se l’episodio della serie tv non ti entusiasma, difficilmente ne sarai distratto dall’abbaiare del cane del vicino. La vista e l’udito sono lì a tenerti incollato allo schermo. Sebbene la storia non ti stia coinvolgendo, comunque beneficia – a livello sensoriale – di due ganci forti, ben saldi: vedi le cose con precisione fotografica, senti parlare i personaggi, ognuno col suo tono, e non sarà né l’abbaiare del cane né qualcosa di sostanzialmente equivalente a farti smettere di vedere quell’episodio della serie tv. Anche perché – diciamolo francamente – potrebbero bastare le tette della protagonista a convincerti a guardalo sino alla fine (e se invece sei una donna, vuoi che non ci sia un equivalente di ciò che le tette sono per gli uomini?).
Ma in scrittura non solo non c’è nulla di tutto questo, non solo mancano le percezioni sensoriali che vincolano alla fruizione dell’opera, ma quelle stesse percezioni possono essere attratte da un’infinità di elementi distrattivi.
E non dirmi – ti prego – che il lettore leggerà comunque, se è un vero lettore, se è interessato a ciò che sta leggendo, perché i patti non erano questi. Se stai leggendo questo manuale, e sei arrivato sin qui, è perché vuoi scrivere – nella più favorevole delle ipotesi – per gente che può smettere di leggere per 1001 motivi, senza essere incolpata di nulla (se lo hai dimenticato, corri subito al modulo 1).
Chi ti sta leggendo, non ti deve nulla: i tuoi lettori non sono la tua mamma e il tuo papà, la tua fidanzata o il tuo migliore amico, e neppure un altro scrittore che deve ricambiarti il succhiotto che gli hai fatto tu, per la porcheriola che ha scritto lui.
Tu non vuoi questi lettori, o meglio, questi lettori – se pure ci sono – per te non significano nulla.
Il tuo lettore è una figura anonima, esigente, severa e impaziente, e diciamo pure insofferente per il tempo che ti sta dedicando, e che, al di là di tutto, ha una pletora di alternative per svagarsi (cinema, teatro, serie tv, fumetti, podcast, videogiochi, giochi di ruolo, audio-libri, musei, internet…).
E già un mezzo miracolo che un lettore tiepido abbia tra le mani il tuo libro, perché i lettori – a differenza dei fruitori di tutte le altre forme d’arte – è difficile che si accostino a un’opera che non sia nelle loro corde.
Posso pure trascorrere un pomeriggio a una mostra di arte moderna, anche se l’arte moderna non mi interessa granché e non ne capisco nulla, e trovare comunque l’esperienza gratificante e formativa, magari per merito di una guida preparata, capace di porgermi con immediatezza il senso di ciò che osservo, e finire pure col consigliare ad altri di visitarla. Ma è decisamente più improbabile che girovagando per una libreria mi ritrovi tra le mani un romanzo con al centro le avventure di un pittore contemporaneo deciso a sfondare nel duro mondo dell’arte moderna. Se non sono già fasato sull’arte moderna, la narrativa sull’arte moderna potrà attirarmi, forse sì, forse no, in ragione di una serie di imponderabili favorevoli bilanciati da altrettanti imponderabili sfavorevoli, un po’ come avere “testa” o “croce” nel lancio di una moneta.
E l’esempio lo puoi mutuare – a tuo piacimento – su tutto il resto: cinema, teatro, serie tv, fumetti, e prosegui pure da solo con tutte le offerte a catalogo.
È già un mezzo miracolo che un lettore tiepido abbia tra le mani il tuo libro, e tu pensi che possa verificarsi spontaneamente l’altra metà del miracolo? Speri davvero di poter blandire il lettore con una forma comunicativa dove non si vede, non si sente e non si tocca niente? Pensi davvero che siano sufficienti il talento naturale e l’ispirazione?
Estratto dalla “Lezione 5 – Lavorate, lavorate, l’ispirazione arriverà”, di Giuseppe Pontiggia.
Come se non bastassero i continui bombardamenti esterni al fragilissimo mondo della pagina – il cane che abbaia, il citofono che suona, la finta urgenza di rapido un giro sui social che poi dura due ore – come se non bastasse tutto questo, ecco arrivare il fuoco amico: lo scrittore che si auto-sabota, che distrugge la sua stessa creatura, infilando nella pagina ogni sorta di elemento distrattivo.
Eccoti un primo elenco di orrori con cui lo scrittore imbratta la pagina, nel tentativo inconscio di scacciarne via il lettore quanto prima.
1) Utilizzo dei segni “doppio minore” (<<) e “doppio maggiore” (>>) al posto delle virgolette caporali («…») per marcare i dialoghi.
Sinceramente: uno così pigro, sciatto e svogliato, da collocare le battute di dialogo tra i segni <<….>> anziché tra i segni «…», cosa vuoi che abbia mai potuto scrivere di interessante?
Gli editori (non a pagamento) cestinano all’istante, senza neppure leggerli,
i testi in cui vedono i segni <<….>> al posto delle virgolette caporali «…».
Se non sei in grado inserire le virgolette caporali – il che rimane comunque preoccupante –
allora usa le virgolette alte (“...”), che non sono lo standard italiano,
ma almeno sono uno standard (anglosassone).
Qui siamo sulla vetta della trasandatezza:
non ci siamo neppure dati la pena di battere due volte sui segni di minore e di maggiore,
per creare un simbolo che almeno alla lontana evocasse le virgolette caporali.
No, neppure questo: semplicemente un segno di minore e uno di maggiore.
Si ripete ossessivamente che per scrivere bene bisogna prima leggere molto,
ma bisogna essersi tenuti signorilmente distanti da qualsiasi libro per tutta la vita,
per concepire questo segno assurdo di marcatura dei dialoghi.
2) Battute di dialogo pronunciate da personaggi diversi, e tuttavia scritte sulla stessa linea della pagina.
Sembra impossibile che qualcuno possa commettere questo errore, non è vero? Eppure…
Vero, purché non si confonda una condizione necessaria (leggere molto)
con una sufficiente (studiare a fondo le regole e i principî di scrittura).
E a ogni modo, per quanto si legga, per quanti testi si passino al setaccio,
mai se ne troverà uno con delle battute di dialogo sulla stessa linea di testo,
quando pronunciate da due personaggi diversi.
Dietro a una forma così sciatta, quale sostanza potrà mai esserci?
3)
Mancanza di uno standard, eccesso di notazione ed errori di notazione: battute di dialogo
collocate ora tra virgolette caporali («…») ora tra virgolette alte
(“…”) ora annunciate da un trattino (-) peraltro confuso con la lineetta (–); punteggiatura ora interna alla
battuta di dialogo, ora esterna, ora entrambe le cose; utilizzo di uno
stesso segno per indicare cose diverse, a esempio l’impiego dei tre
puntini di sospensione (…) per comunicare sia un tono di voce calante, sia l’interruzione improvvisa di ciò che il personaggio sta
dicendo (che andrebbe propriamente segnalato con l’em-dash, una linea “—” un po’ più lunga della norma); utilizzo delle virgolette caporali per delimitare le battute di
dialogo e utilizzo delle virgolette alte per delimitare i pensieri,
anche quando i pensieri non hanno bisogno di alcun segno identificativo (come avviene quando si scrive in Prima al Presente); and so on…
La battuta di dialogo si apre con una virgoletta caporale («) e si chiude con un trattino (-)
per poi riaprirsi con un nuovo trattino (-) e richiudersi con un altro trattino (-):
è una scelta che – uno – sta confondendo il trattino (-) con la lineetta (–),
per poi riaprirsi con un nuovo trattino (-) e richiudersi con un altro trattino (-):
è una scelta che – uno – sta confondendo il trattino (-) con la lineetta (–),
e – due – si presenta eterodossa, perché la lineetta (qui scambiata con il trattino)
per convenzione non vuole la chiusura, a differenza delle virgolette.
La battuta si riapre poi con un altro trattino (-) e si chiude con la caporale (»).
Da altro punto di vista, l’autore ha infilato tra due virgolette caporali («…»)
sia la battuta di dialogo sia i cosiddetti beat, delimitandoli con il trattino (-),
e sarebbe interessante sapere dove abbia visto questa convenzione di scrittura,
La battuta si riapre poi con un altro trattino (-) e si chiude con la caporale (»).
Da altro punto di vista, l’autore ha infilato tra due virgolette caporali («…»)
sia la battuta di dialogo sia i cosiddetti beat, delimitandoli con il trattino (-),
e sarebbe interessante sapere dove abbia visto questa convenzione di scrittura,
che rimane comunque da stigmatizzare per l’eccesso di notazione.
e allora si ripristina l’ortodossia delle virgolette caporali («Come no?!»).
Due convenzioni diverse nello stesso testo,
una ortodossa, l’altra eterodossa e con un errore di notazione:
un bello strike!
Qui abbiamo un’orgia di convenzioni:
battute che si aprono con le virgolette alte e si chiudono col trattino (al solito, scambiato per lineetta),
altre rinchiuse tra virgolette alte, altre ancora gestite con un ibrido tra virgolette e trattini.
Ma – sul serio – chi non vuol dedicarsi a un minimo di pulizia grafica a costo zero,
che alla fine non richiede nessuno sforzo, cosa potrà mai aver scritto di interessante?

Fai la cortesia: studia e impara un minimo di notazione.
Il trattino (-) serve spesso per la scomposizione in sillabe dentro le battute di dialogo,
quando ad esempio il personaggio scandisce le parole («me-ra-vi-glio-so»)
o quando hai una folla che fa partire un coro («Dis-cor-so, dis-cor-so!»).
La lineetta (–) puoi usarla per annunciare la battuta di dialogo,
sapendo però che per convenzione unanime non vuole la chiusura
(non racchiudi cioè la battuta di dialogo tra due lineette)
e già questo dovrebbe scoraggiarti nell’impiego, tant’è che non la usa quasi nessuno.
L’em dash (—) è una linea più lunga della norma
e serve a segnalare l’interruzione della battuta di dialogo
(esempio: «Non ti preocc—» Un boato mi fa sobbalzare).
Per tua informazione: il trattino, in inglese, si chiama hyphen, e la lineetta si chiama en-dash.
Ma se non hai voglia di imparare convenzioni di scrittura così semplici,
cosa pensi di poter mai scrivere di interessante?
Lo hai riconosciuto?
È stralciato dalla traduzione italiana del best-seller Cinquanta sfumature di grigio.
Il romanzo è in Prima al Presente, e uno dei vantaggi della scrittura in Prima al Presente
È stralciato dalla traduzione italiana del best-seller Cinquanta sfumature di grigio.
Il romanzo è in Prima al Presente, e uno dei vantaggi della scrittura in Prima al Presente
è proprio nel non aver bisogno di nessun segno speciale per indicare i pensieri,
che invece qui sono segnalati – con eccesso di notazione – tra le virgolette alte.
La pubblicazione e il successo commerciale non santificano la cattiva scrittura.
che invece qui sono segnalati – con eccesso di notazione – tra le virgolette alte.
La pubblicazione e il successo commerciale non santificano la cattiva scrittura.
4) Utilizzo del corsivo a sentimento, a intuito, a presunto buon senso, in una parola, a cazzo.
Il corsivo è un elemento di potenziale distrazione. Il lettore legge una parola in corsivo e si chiede “perché è scritta in corsivo?”, e se il lettore si ferma per farsi domande, di qualunque tipo, tu, scrittore, hai fallito. Il corsivo – con buona pace di Elisa Esposito – è una cosa seria. Ha regole di utilizzo molto precise, all’interno del patto narrativo col lettore, e queste regole devono essere rigidamente rispettate, affinché il lettore sappia da subito cosa il corsivo rappresenta all’interno del testo, e non ne venga mai distratto quando lo incontra in fase di lettura.
Per scrivere bene bisogna leggere molto,
ma per quanto si legga non si troverà mai un simile obbrobrio:
il corsivo per indicare una battuta di dialogo.
Uno dei grandi vantaggi della scrittura in Prima al Presente
è nel non aver bisogno di nessun segno speciale per segnalare i pensieri;
ed è davvero un gran vantaggio, perché si guadagna in pulizia della pagina
e perché i segni speciali (il corsivo o le virgolette alte) restano liberi per codificare altri aspetti.
Perché, allora, i pensieri sono qui scritti in corsivo?
La domanda è retorica, e non ti industriare a trovare risposte o a giustificare la scelta.
I pensieri sono in corsivo perché è stato commesso un errore di notazione, punto e basta.
E allo sbaglio di notazione si associa un grave errore di sostanza,
che discuteremo nel modulo 22 dedicato alla progettazione e realizzazione delle scene.
Ci vuole una straordinaria abilità tecnica per scrivere una “scena confusa”,
associata cioè a uno “stato alterato di coscienza”,
ma serve tutta l’imperizia del mondo per scegliere di aprire un racconto con una “scena confusa”,
visto che l’obiettivo delle prime righe della narrazione è far capire, con quanta più chiarezza possibile,
chi è il personaggio, dove si trova e qual è il suo obiettivo.
5) Utilizzo del maiuscolo per segnalare un tono di voce più alto, mutuando impropriamente ciò che avviene nella comunicazione virtuale, su forum o chat, e a volte anche nei fumetti.
Peccato solo che il mondo della pagina non è né un forum né una chat né un fumetto, e le parole scritte tutte in maiuscolo – a meno che non siano usate in contesti appositamente costruiti – finiscono solo con l’attirare l’attenzione su di sé, distraendo dalla lettura.

Un tono di voce più alto non si segnala mai scrivendo tutto in maiuscolo.
Il tono più alto è gestito con dialogue-tag e beat .
e se possibile dovrebbe risultare implicito nella dinamica stessa della scena.
6) Nessuna attenzione nell’evitare rime, e più in generale scampanellii tra parole, cose del tipo – per rendere l’idea – “mia mamma mi manda un messaggio ogni mattina”, con la micidiale sequenza mi-ma-mi-ma-me-ma, da bambini delle elementari che stanno imparando a sillabare.
Ci sarà un motivo se la prima delle quaranta regole di scrittura di Umberto Eco è proprio “Evita le allitterazioni anche se allettano gli allocchi”, non credi?
Tu
non vuoi questo micidiale effetto di ripetizione –
cinquant’anni, cinque figli –
e non lo vuoi, primo, perché lo hai rubato
a De Gregori
(“di cinquant’anni, di cinque figli, venuti al modo come
conigli…”)
e, secondo, perché non vuoi che l’attenzione del lettore sia
attratta dall’anafora.
Tu non vuoi che il lettore pensi “Quant’è bravo lo scrittore a
usare le figure retoriche”.
7) Utilizzo gratuito e incoerente (quindi sbagliato) delle figure retoriche; poco importa se finalizzato a impressionare il lettore o ad auto-compiacersi della propria bravura nel giocherellare con le parole, perché un errore rimane comunque un errore, quale che sia il motivo per cui si riteneva – sbagliando – di stare facendo giusto.
Breaking news: il lettore tiepido non si impressiona e non è in questi funambolismi che si mostra la bravura di uno scrittore nel dominare le parole.

2 capoversi, 85 parole, 509 battute (510 per correggere “un pelle” in “una pelle”)
per dire semplicemente che Annarosa aveva la pelle e gli occhi neri.
All’errore grave se ne somma uno gravissimo:
“neri come il cielo nero” fa già parecchio ridere
– alla fine è come dire “nero come il nero” –
ma è la qualificazione successiva
– “in quelle notti di bivacco in cui le nuvole nascondevano le stelle” –
a mandare proprio in totale confusione:
perché se ci sono le nuvole, il cielo non è nero.
8) Muri di testo: sequenze lunghissime in cui non si va mai a capo, che predispongono male il lettore non appena cadono sotto la sua percezione visiva, ancor prima di leggerle, perché comunicano confusione sul loro contenuto e incertezza su ciò che l’autore voleva dire.
Che poi questo brano non è neanche malaccio,
ma ritrovarsi di fronte a muri di testo scoraggia sempre la lettura.
9) Abbreviazioni di nomi, cose o città, non si capisce se per scrupolo, timore o pudore, se per suscitare curiosità, o perché si crede che vi sia chissà quale merito artistico in questa idiozia.
Spoiler: gli scrupoli sono fuori luogo, la curiosità non c’è, e non serve nessuna abilità per fare questa stupidata.
Cosa? Come dici? Lo faceva Kafka? Interessante. E, dimmi, tu sei forse Kafka? Scrivi anche tu a cavallo tra l’800 e il 900? Oppure tu sei tu e scrivi nel 2023? Ecco, appunto.
 Arrivati alla fine non si può fare a meno di fermarsi per chiedersi cosa sia “M.”.
Arrivati alla fine non si può fare a meno di fermarsi per chiedersi cosa sia “M.”.Milano? Mantova? Messina? Modena? Milazzo? Mestre? Matera?
Ma poi, a Milazzo, ci sarà un centro cardiologico?
Aspetta, fammi controllare: no, non c’è.
Ma quindi, se uno di Milazzo ha problemi di cuore, come fa?
Dove sarà il centro cardiologico più vicino a Milazzo?
Aspetta, fammi controllare…
Ecco cosa succede, quando scrivi “M.”.
Ecco cosa succede, quando scrivi “M.”.
10) Lost in translation: mancata consapevolezza di ciò che si può ragionevolmente rappresentare sulla pagina – a un estremo – di ciò che invece è impossibile rendere in qualunque forma – all’estremo opposto – e di tutte le sfumature intermedie.
Qui converrà spendere due parole.
Il mondo della pagina, come ogni mondo, è caratterizzato da cose percepibili, in misura di volta in volta da qualificare, e da altre sfuggenti.
Ti chiedo un piccolo sforzo di fantasia: suvvia, in fondo ambisci a essere uno scrittore, no?
Immagina un cane antropomorfo, di professione regista, che abbia girato un film in cui di quando in quando vi sono scene monopolizzate dagli ultrasuoni. Per noi esseri umani, ipotetici spettatori del film, quelle scene sono momenti di silenzio assoluto.
Il cane-regista ha il suo bel da fare nel difendere la propria scelta stilistica, nel dire che lui gli ultrasuoni li ha messi e li sente, eccome se li sente. D’accordo, lui, il cane antropomorfo, regista del film, l’ultrasuono lo sente, ma noi essere umani no. Lost in translation: nel passare dal mondo del cane antropomorfo al mondo percepibile da noi umani, nel tradurre l’uno nell’altro, l’ultrasuono è andato perduto, a causa delle limitazioni percettive dello spettatore.
Esiste il mondo reale – il nostro mondo, il mondo in cui viviamo, che sperimentiamo con i cinque sensi – e poi esiste il mondo della pagina – reale anch’esso, con i suoi personaggi e le loro vite – che va però tradotto a noi lettori per rendercelo intelligibile, per farci capire cosa stia avvenendo sulla pagina, sapendo che nessuno dei cinque sensi può venire direttamente in aiuto alla nostra comprensione.
Questo è un punto capitale, e non sarà mai abbastanza ripetuto: nessuno dei cinque sensi ci supporta, quando leggiamo.
La lettura di narrativa funziona tutta e solo per evocazioni: leggo una parola, evoco l’immagine, il suono, il sapore, l’odore corrispondente a quella parola; quindi la parola sulla pagina è efficace nella misura in cui può essere evocata con precisione; altrimenti è sterile, anche quando (fintamente) precisa.
“Non importa quel che mangi, conta solo quel che assimili” è uno dei mantra dei body-builder. L’organismo – se ben ricordo – non può assimilare più di 20-30 grammi di proteine per pasto. L’eventuale eccesso viene smaltito, quindi – uno – non serve allo sviluppo muscolare, e – due – affatica inutilmente il fisico che lo deve eliminare.
Ogni volta che gli occhi leggono una parola, il cervello avvia la simulazione di quella parola; se non riesce a simularla – o, il che è lo stesso, se viene lasciato totalmente libero di simulare quel che vuole – allora si affatica inutilmente, proprio come il fisico che deve liberarsi delle proteine in eccesso.
Aver ben chiaro quali siano le parole che il cervello può simulare, e sapere in che misura riesce effettivamente a farlo, è fondamentale per non riempire la pagina di segni grafici, apparentemente accurati, ma di fatto perduti (lost) in fase di simulazione (translation).
non c’è modo, per quanto ti puoi sforzare, di rendere la musica nel mondo della pagina.
Infilare musica nella pagina equivale a comportarsi come il cane antropomorfo
che mette gli ultrasuoni in un film destinato agli esseri umani.
Leggiamo “do diesis della seconda ottava, quinto della sinistra” e cosa dovremmo sentire?
Poi leggiamo “sol diesis della quarta ottava” e, di nuovo, cosa mai dovremmo sentire?
E come facciamo a distinguere, in fase di lettura, i due suoni?
E quando leggiamo “Zum-pa-pà-Zum-pa-pà” quale intonazione dovremmo dargli, esattamente?
Ci sono infiniti modi in cui ognuno di noi può simulare uno “Zum-pa-pà-Zum-pa-pà”
e infiniti con cui può poi rallentarlo in uno “Zummm-pappp-pà-Zummm-pappp-pà”.
E l’obiettivo dello scrittore non è lasciare il lettore libero di immaginare quel che vuole,
quasi indipendentemente da ciò che sta scritto sulla pagina
(perché affannarsi a cercare le parole giuste, se poi ognuno resta libero di capire quel che vuole?).
Non è in questo senso – proprio no! – che il lettore partecipa al testo.
Il lettore deve immaginare quel che lo scrittore vuole che immagini,
e rimanere invece libero di immaginare quel che vuole lui, lettore,
riguardo alle cose che lo scrittore ha deciso di lasciare alla sua immaginazione.
Non riuscirai mai a rendere la musica in scrittura,
perché non riuscirai mai a indirizzare l’immaginazione del lettore,
a meno che non si tratti di musiche universalmente note:
l’inno nazionale, “Bella ciao”, “Volare” di Modugno e…
in tutta sincerità non mi viene in mente nient’altro.
Puoi portare la musica nel mondo della pagina,
solo ed esclusivamente in questi casi,
senza rischi di lost in translation.
11) …
12) …
Prego, continua tu: compila da solo i punti 11 e 12 (e 13, 14, 15, …) richiamando alla memoria tutte le cose, dentro il testo, che ti hanno distratto durante le tue letture.
per l’invio delle opere da parte di aspiratnti autori.
Sembra pazzesco dover precisare simili ovvietà,
ma evidentemente, se ne hanno sentito il bisogno,
è perché nel tempo avranno ricevuto simili orrrori…
Questa piccola bottega degli orrori rievoca, qualificandole, le annotazioni generali del modulo 1: rende palese la remota distanza dei più dal linguaggio pagina; smaschera l’illusione di poter parlare spontaneamente nel linguaggio degli scrittori; stigmatizza la tendenza a scrivere, solo perché scrivere si può.
E se pensi che queste cose siano meri formalismi privi di sostanza, fissazioni stupide da fanatici, ho una notizia per te: sei sulla via più breve verso il disastro perfetto.
Questi errori “di forma” sono un campanello d’allarme per chi vi sta intorno: nessuno vorrà mai lavorare con voi – a nessun livello: né da editor né da insegnante – perché vi scorgerà l’arrivo di una valanga di errori “di sostanza”, impossibili da correggere; e pure i lettori tiepidi non ne vorranno sapere più nulla di ciò che scrivete, se tutto quel che siete capaci di offrire è un testo che si fa notare per le sue stranezze anziché per i contenuti.
Ma sì, dai, attrai pure l’attenzione sulla grafica e rendi il testo incomprensibile:
è proprio questo che devi fare, per essere come Dio nella creazione.
La pagina – checché ne pensino le anime belle e gli inguaribili romantici – è un mondo scritto in codice, di cui lo scrittore deve fornire al lettore la chiave di decodifica con naturalezza, in modo implicito, se non subliminale.
Adottare i migliori standard di scrittura – che consentono al lettore di capire all’istante cosa stia accadendo nel mondo della pagina, senza farsi domande, senza distrarsi, perché in scrittura nulla cade direttamente sotto i nostri sensi, e tutto deve essere evocato tramite l’intermediazione del cervello – adottare i migliori standard, dicevo, non è neanche un requisito, ma un prerequisito, per chi ha l’ambizione di scrivere.
Fermati e fatti una domanda, nel tuo stesso interesse: se non conosci gli standard di scrittura, se non sei neppure capace di sceglierne uno e rispettarlo, quanto lontano pensi di poter arrivare?
Adottare i migliori standard di scrittura – che consentono al lettore di capire all’istante cosa stia accadendo nel mondo della pagina, senza farsi domande, senza distrarsi, perché in scrittura nulla cade direttamente sotto i nostri sensi, e tutto deve essere evocato tramite l’intermediazione del cervello – adottare i migliori standard, dicevo, non è neanche un requisito, ma un prerequisito, per chi ha l’ambizione di scrivere.
Fermati e fatti una domanda, nel tuo stesso interesse: se non conosci gli standard di scrittura, se non sei neppure capace di sceglierne uno e rispettarlo, quanto lontano pensi di poter arrivare?

Fai attenzione!
La pagina è un mondo fragile:
basta un niente a strapparlo, accartocciarlo, bucarlo, a distruggere la sospensione dell’incredulità.
Usa standard sobri, discreti, minimalisti, ampiamente diffusi, a cui il lettore è abituato,
e quando te ne discosti fallo a ragion veduta e con uno scopo preciso,
sempre e solo nella prospettiva di rafforzare il patto narrativo.
E non offendere la tua intelligenza, con domande del tipo
“E allora Saramago, Nobel per la letteratura, che scrive i dialoghi senza virgolette?”.
Perché la mia risposta – se proprio hai deciso di mancare di rispetto a te stesso – sarà la solita:
“Tu sei forse Saramago, Premio Nobel per la letteratura?”.
Non puoi scrivere le battute di dialogo fuori dalle virgolette.
Quando anche tu vincerai un Premio Nobel per la letteratura,
allora, sì, anche tu potrai scrivere i dialoghi senza virgolette,
e potrai pure inventare una notazione tutta tua, se ne avrai voglia.
Prima di allora, fai la cortesia: uniformati agli standard.
Grazie.
Ancora una parola… sulle parole.
“Disposte per ogni servizio, pronte ad ogni viaggio, mercenarie per ogni guerra, saltellanti, fugaci, imprecise, sono schiave eccellenti, e capaci maestri di casa” - nella suggestiva immagine di Prezzolini – “Economizzano le nostre facoltà, perché spesso ci servono a pagare gli altri, senza contar che noi stessi ci contentiamo di parole. Sono instancabili, inconsumabili, numerosissime. Fan da paciere e ci evitano le liti. Versano l’olio degli eufemismi negli ingranaggi sociali, perché stridano meno. Ci procacciano femmine ed onori. Ci risparmiano spesso di pensare e ci fan passare per pensatori. Prosseneti, medici, mercanti, economi – cosa mirabile – non ci derubano mai. Non vogliono stipendio e si danno a chi meglio le adopra, per qualunque causa, come se fossero di là dal bene e dal male. Non ci gravano la memoria coi loro benefici, non ci presentano il conto delle loro forniture. Se sparliamo di loro ci servono egualmente, non ci rimproverano di ingratitudine e non ci rinfacciano nemmeno la nostra contradizione d’aver detto male delle parole con le parole stesse”.
“Disposte per ogni servizio, pronte ad ogni viaggio, mercenarie per ogni guerra, saltellanti, fugaci, imprecise, sono schiave eccellenti, e capaci maestri di casa” - nella suggestiva immagine di Prezzolini – “Economizzano le nostre facoltà, perché spesso ci servono a pagare gli altri, senza contar che noi stessi ci contentiamo di parole. Sono instancabili, inconsumabili, numerosissime. Fan da paciere e ci evitano le liti. Versano l’olio degli eufemismi negli ingranaggi sociali, perché stridano meno. Ci procacciano femmine ed onori. Ci risparmiano spesso di pensare e ci fan passare per pensatori. Prosseneti, medici, mercanti, economi – cosa mirabile – non ci derubano mai. Non vogliono stipendio e si danno a chi meglio le adopra, per qualunque causa, come se fossero di là dal bene e dal male. Non ci gravano la memoria coi loro benefici, non ci presentano il conto delle loro forniture. Se sparliamo di loro ci servono egualmente, non ci rimproverano di ingratitudine e non ci rinfacciano nemmeno la nostra contradizione d’aver detto male delle parole con le parole stesse”.
C’è di che rimanere estasiati davanti al potere delle parole, non è vero?
Già. Siediti e fai un bel respiro, ché ho una notizia tremenda: non hai capito nulla delle parole, proprio nulla, e se non hai capito nulla delle parole, che sono il materiale con cui devi lavorare, anzi l’unico materiale a tua disposizione, quanto sei distante dallo scrittore che ambisci a diventare?
Non hai capito nulla delle parole perché sei caduto nel più micidiale e letale degli equivoci, quello che confonde la parola scritta con la parola orale.
Pontiggia dedica alla differenza tra i due tipi di parola – scritta e orale – la prima riga della prima lezione sull’arte dello scrivere: “Chi scrive colloca le parole in un contesto artificiale, quello della pagina. Chi parla, invece, accompagna la parola con il gesto, il tono, la pausa, lo sguardo”.
Già. Siediti e fai un bel respiro, ché ho una notizia tremenda: non hai capito nulla delle parole, proprio nulla, e se non hai capito nulla delle parole, che sono il materiale con cui devi lavorare, anzi l’unico materiale a tua disposizione, quanto sei distante dallo scrittore che ambisci a diventare?
Non hai capito nulla delle parole perché sei caduto nel più micidiale e letale degli equivoci, quello che confonde la parola scritta con la parola orale.
Pontiggia dedica alla differenza tra i due tipi di parola – scritta e orale – la prima riga della prima lezione sull’arte dello scrivere: “Chi scrive colloca le parole in un contesto artificiale, quello della pagina. Chi parla, invece, accompagna la parola con il gesto, il tono, la pausa, lo sguardo”.
Chi magnifica il potere delle parole sembra non accorgersi che quel potere proviene in larga misura dal poter accompagnare la parola con la postura, l’intonazione, le sospensioni, la mimica, la gestualità, i giri di frase, nonché dall’avere davanti le persone a cui si parla, e quindi dal poter sfruttare ciò che l’ambiente rimanda, se necessario rielaborando non solo la forma ma persino il contenuto di quel che vuole dire: il potere delle parole è un potere riflesso, eterodiretto, come lo è lo splendore della luna, possibile solo perché il Sole le getta addosso i suoi raggi.
Quando ascoltiamo un bel discorso – che ci affascina e ci coinvolge – abbiamo la sensazione, a pelle, che l’effetto sia dovuto alle parole con cui ha preso forma (“coma parla bene” è il più classico dei commenti); ma è un’illusione percettiva, come credere che la luna splenda di luce propria. È stato sperimentalmente accertato che la parola in sé non pesa più del 10% nell’efficacia della comunicazione orale. Tutto il resto è indotto dalla qualità della recitazione (intesa in senso ampio).
Ricordi la reazione del Presidente francese Sarkozy e della Cancelliera tedesca Merkel alla richiesta di esprimere un’opinione sul premier italiano Berlusconi? Si scambiarono uno sguardo veloce, sorrisero appena, e tornarono a fissare i giornalisti, accentuando il sorriso. Avevano risposto… senza parlare, con un’efficacia – e se vogliamo una violenza – che nessuna parola avrebbe mai potuto realizzare.
Senza parole. In tutti i sensi.
Oppure pensa al modo più semplice per far sì che qualcosa rimanga scolpita nella memoria di chi ti ascolta: fare una pausa prima di dirla, pronunciarla scandendo le parole con voce bassa e profonda, e infine far seguire un’altra pausa, così da incorniciare tra due silenzi ciò che si vuol comunicare, creando prima un “effetto aspettativa”, e dopo un “effetto eco”. Semplicissimo, non è vero? Chiunque può farlo, e con un minimo di allenamento si ottengono straordinari effetti di incisione delle parole nella testa dell’ascoltatore. Ma prova a replicarlo sulla pagina, se ne sei capace. Non ce la farai mai. La più elementare tecnica persuasiva nell’oralità diventa impossibile in scrittura.
Non sei ancora convinto? Prova allora a trascrivere una delle meravigliose lezioni del professor Barbero, a inchiodare nel mondo della pagina ciò che nasce nel mondo dell’oralità, e poi a leggere ciò che hai trascritto, senza più il sostegno della recitazione di Barbero. Ti apparirà tutto insopportabilmente sciatto, frammentato, confuso (sempre ammesso che tu riesca ad arrivare alla fine della trascrizione, che la noia non sopraggiunga e ti faccia desistere).
La forza delle parole – delle parole in sé, avulse dal resto – è una forza illusoria, come il bambino che si illude di aver battuto il papà a braccio di ferro.
La parola – nell’oralità, nel mondo reale – pesa al più il 10%. Perché pensi – su quali basi scientifiche ritieni – che possa aumentare d’importanza, quando la si trasferisce nel mondo della pagina?
Il mondo reale è fatto di parole e recitazione, quindi nel mondo della pagina – che ne rappresenta la versione elegante – lo scrittore fronteggia due problemi. Il primo: scegliere le parole migliori da mettere in bocca ai propri personaggi (che comunque, come nel mondo reale, peseranno al più il 10%). Il secondo: realizzare la migliore recitazione per i propri personaggi, che sostenga e valorizzi quelle parole. Con una complicazione in più, rispetto al mondo reale: che la recitazione dei personaggi va essa stessa realizzata con le parole.
Parole, parole, parole: sulla pagina ci sono solo parole; nessuna immagine, nessun suono, nessun odore, niente di niente, solo segni grafici da decodificare prima e da tradurre in cose concrete poi, attraverso un processo di evocazione che implica l’intermediazione del cervello.
La parola – nell’oralità, nel mondo reale – pesa al più il 10%. Perché pensi – su quali basi scientifiche ritieni – che possa aumentare d’importanza, quando la si trasferisce nel mondo della pagina?
Il mondo reale è fatto di parole e recitazione, quindi nel mondo della pagina – che ne rappresenta la versione elegante – lo scrittore fronteggia due problemi. Il primo: scegliere le parole migliori da mettere in bocca ai propri personaggi (che comunque, come nel mondo reale, peseranno al più il 10%). Il secondo: realizzare la migliore recitazione per i propri personaggi, che sostenga e valorizzi quelle parole. Con una complicazione in più, rispetto al mondo reale: che la recitazione dei personaggi va essa stessa realizzata con le parole.
Parole, parole, parole: sulla pagina ci sono solo parole; nessuna immagine, nessun suono, nessun odore, niente di niente, solo segni grafici da decodificare prima e da tradurre in cose concrete poi, attraverso un processo di evocazione che implica l’intermediazione del cervello.
Sembra assurdo, ma sopravvalutare il valore delle parole può far perdere il controllo della scrittura: non si riesce più a distinguere ciò che sta effettivamente scritto sulla pagina, e può quindi essere evocato e integrato dal lettore, da ciò che sta solo nella testa della scrittore e lì è rimasto, e quindi non può in alcun modo essere conosciuto; si è convinti di aver veicolato un messaggio perché inconsapevolmente si è colorata la pagina con la propria emotività, quando il lettore può sapere solo quel che si trova effettivamente sulla pagina, nell’esatto ordine in cui gli è stato presentato.

Estratto dalla “Lezione 4 – Guardati, o poeta, dalle notti di luna” di Giuseppe Pontiggia.
Sembra assurdo, ma si ambisce a scrivere e si dimentica che non siamo al cinema, dove ogni frame restituisce una moltitudine di dettagli percepibili in un solo colpo, tramite la vista.
La scrittura è sequenziale, anzi, è la più sequenziale di tutte le forme d’arte, perché funziona parola per parola, una parola dopo l’altra, perciò non basta semplicemente scrivere le cose purchessia, ma è cruciale l’ordine con cui le si scrivono, è vitale che ogni parola arrivi al momento giusto, né in anticipo né in ritardo, perché la scrittura è l’arte di rispettare gli appuntamenti (con le parole).

Ritorna il pezzo su Annarosa, già citato al punto 7 della lista di cose da non fare,
su cui possiamo rilevare un altro errore grave di scrittura.
Immaginiamo di esserci digeriti tutta la retorica insulsa sulle fattezze fisiche di Annarosa.
Okay, d’accordo: ma ora, alla fine di tutta questa pseudo-poesia… chi è Annarosa?
Uno legge questa descrizione simil-poetica di Annarosa e… quale immagine si forma nella testa?
Io l’ho immaginata come una bambina, tra i 5 e gli 8 anni.
Non saprei dirne il motivo, ma per me è così: Annarosa è una bambina.
Forse, chissà, l’ho visualizzata come una bambina per questa insistenza sul cacao,
che nella mia immaginazione rimane un alimento collegato più che altro ai bambini.
O forse perché si fa un gran parlare del dramma dei migranti
e le situazioni che restano più impresse sono sempre legate a dei bambini.
O forse perché molte associazioni umanitarie utilizzano le immagini di bambini di colore,
per sollecitare la nostra generosità e spingerci a donazioni e contributi finanziari.
Potrei pure scavare a fondo nella mia psicologia, alla ricerca dei motivi per cui Annarosa
– per me, in base a ciò che l’autore mi ha detto – è una bambina, ma comunque il fatto rimane:
Annarosa – per me, in base a ciò che lo scrittore mi ha detto – è una bambina.
Perché il lettore completa sempre la scena, con la sua fantasia, con la sua immaginazione,
appoggiandosi a ciò che lo scrittore ha messo esplicitamente sulla pagina.
E un’accortezza minimale dello scrittore, davvero un requisito minimo,
sta nell’evitare che il lettore possa immaginare cose che poi si riveleranno false,
quando nuovi elementi informativi sopraggiungeranno nel mondo della pagina.
Si chiama – in gergo tecnico – “riconfigurazione della scena”
ed è tra le cose peggiori in assoluto che possono accadere:
essersi formati una certa idea di un personaggio, di un luogo, di una situazione,
ed essere poi obbligati a modificare tutto nel corso della lettura,
perché solo dopo arrivano le informazioni esatte, precise,
che caratterizzano personaggi, luoghi e situazioni.
Aver immaginato Annarosa come una bambina
– perché l’autore si è voluto baloccare con la retorica –
e venir poi a sapere che non solo non è una bambina,
ma è una gran bella ragazzona, di quelle dure e toste,
è tra le esperienze più frustranti che un lettore tiepido può vivere.
E siccome tu scrivi per lettori tiepidi…
Invece di presentare il personaggio dall’esterno
– stilandone una vaga carta di identità artistoide, col serio rischio di essere fraintesi dal lettore –
entriamo dentro la scena e facciamolo agire.
Piazziamo Annarosa davanti a uno specchio, e facciamola truccare,
oppure facciamole mettere una qualche crema di bellezza.
Già questo semplice gesto darà un orientamento preciso su Annarosa,
perché se mi sto truccando da sola, davanti a uno specchio,
è molto probabile che io sia una ragazza, e non una bambina.
Ragioniamo poi sui trucchi o sulla crema,
che dovranno avere un colore in netto contrasto con quello della sua pelle,
così da farlo risaltare, e magari, sì, mettiamole accanto un’amica,
che viene colpita dal contrasto e potrà fare uso dell’immagine del cacao
come battuta di dialogo interna alla scena, e non come parole dello scrittore rivolte al lettore.
Chiaro cosa si deve fare per presentare Annarosa? Sì? Bene. Allora fallo!
Perché se non sei capace di fare una cosa così semplice, come pensi di poter fare il resto?
Sembra assurdo, ma in tanti con velleità di scrittura si illudono che la pagina possa rendere le emozioni con la stessa facilità con cui ci riescono il cinema o il teatro, dove il rapporto con l’opera beneficia della vista e dell’udito, o addirittura con la stessa immediatezza del mondo reale, in cui sono coinvolti tutti e cinque i sensi. E così si illudono di far provare “paura” al lettore semplicemente scrivendo che “la paura sale dalle viscere”, o di farlo godere con frasi del tipo “stavo godendo così tanto” o ancora – e qui siamo al ridicolo – di trasmettergli la sensazione di “coraggio” scrivendo “non ci sono parole per descrivere il coraggio dei sommergibilisti” (sic!).
c’è davvero chi scrive certe cose, illudendosi di suscitare chissà quali reazioni emotive.
Scrivere narrativa significa collocare meri segni grafici, le parole, “in un contesto artificiale” tutto da costruire ed elaborare, affinché sia percepito reale.
Scatenare il processo immaginativo che dal segno grafico conduce alla simulazione in prima persona – come se l’esperienza sulla pagina fosse reale – richiede come prerequisito l’esatta percezione della sfida che si fronteggia, la piena consapevolezza della fragilità del mondo della pagina, di quanto poco possa bastare a far distrarre il lettore, a fargli ritirare la sospensione dell’incredulità, a ricordargli che in fondo sta solo leggendo parole scritte su una pagina, e quindi, in definitiva, a farlo smettere di leggere.
MOTO PERPETUO
Stefano e Luca si scambiarono un sorriso sornione, sotto lo sguardo preoccupato di Valeria, quando il notaio lesse il testamento di loro padre.
Il defunto lasciava liberi i suoi tre figli di dividersi l’eredità come volevano, purché almeno due di loro avessero approvato la ripartizione stabilita.
Il notaio li congedò. “Ci rivedremo quando avrete trovato un accordo”.
Quella notte Valeria si rigirava nel letto senza trovare pace, proprio non riusciva a prendere sonno. Sapeva che Stefano e Luca si sarebbero dividersi l’eredità, 50 all’uno e 50 all’altro, senza che lei avesse potuto far nulla. Non aveva forse stabilito così il padre? Almeno due su tre dovevano essere d'accordo. Eccoli qui: Stefano e Luca, due su tre.
Balzò in piedi e chiamò Stefano, sebbene fosse passata la mezzanotte. “So che volete tenermi fuori, l’ho capito. Va così da sempre, figurarsi adesso”.
Stefano l’ascoltava in silenzio.
Valeria prese coraggio. “Ascolta: io mi accontento di un terzo, e tu puoi prendere i due terzi. Conviene a entrambi, no? Ognuno di noi avrà di più ciò che gli toccherebbe se tu e Luca vi divideste tutto in parti uguali”.
Stefano restò di sasso. Proprio non se l’aspettava. Due terzi di eredità, invece di un mezzo, era davvero un bel salto, soprattutto in quel momento, con tutte quelle spese in vista: l’anno scolastico all’estero del figlio, l’università privata della figlia, l’auto nuova, e poi i lavori nella casa al mare… accidenti se quel denaro gli serviva!
“D’accordo, sorellina, affare fatto: due terzi a me, un terzo a te”.
Non aveva forse detto così il padre? Due su tre dovevano essere d’accordo. Eccoli qui: non più Stefano e Luca, ma Stefano e Valeria, non più metà e metà, ma due terzi e un terzo, però sempre due su tre erano, ed erano d'accordo, e tanto bastava a rispettare la volontà del padre.
Valeria tirò un sospiro di sollievo. “Lo avverti tu Luca? Magari se ne farà una ragione”.
Stefano chiamò Luca. “Scusa per l'orario, ma...”. Gli comunicò la decisione presa con la sorella, e mise giù prima che il fratello potesse proferir parola.
Luca era esterrefatto. Proprio non se lo aspettava, non da Stefano. Li divideva poco più di un anno di età, erano cresciuti come gemelli, avevano un legame forte, un rapporto esclusivo, a cui Valeria, arrivata cinque anni dopo, non era mai riuscita a prender parte, vuoi per la differenza anagrafica vuoi perché femmina. E ora lui, proprio lui, il suo gemello putativo, lo tradiva così?
Luca chiamò subito Valeria. “Perdonami se ti ho svegliata, ma...”. Non si perse in convenevoli e andò dritto al punto. “Perché ti accontenti di un terzo? Potremmo dividerci l'eredità noi due, in parti uguali, 50 io e 50 tu, così avresti di più rispetto all’accordo che hai preso con Stefano". Sospirò. “Che ne dici?”.
A Valeria non parve vero. Dacché era stata esclusa, si ritrovava ora a poter beneficiare di metà eredità. Che colpo!
“D’accordo, anzi d’accordissimo, fratellone mio: 50 a te, 50 a me, e così sia”.
Non aveva forse detto così il padre? Due su tre dovevano essere d'accordo. Eccoli qui: Luca e Valeria.
E fu così che Luca chiamò Stefano per dirgli del suo accordo con Valeria, e Stefano chiamò Valeria per dirle che a lui in fondo sarebbe bastato anche solo un terzo, lasciando volentieri a lei i due terzi, e Valeria naturalmente accettò, così Stefano chiamò Luca per dirgli del nuovo accordo con Valeria, e Luca propose a Stefano di dividere equamente l'eredità con lui, 50 e 50, come in fondo avevano stabilito sin dall'inizio, e Stefano accettò e chiamò Valeria per informarla del cambio di programma, e Valeria chiamò Luca…
E andarono avanti a telefonarsi per tutta la notte, e continuarono il giorno dopo e quello dopo ancora, e ancora, ancora e ancora… il notaio morì, suo figlio ne prese il posto, e Valeria chiamò Stefano che chiamò Luca che chiamò Valeria…
Il racconto Moto perpetuo avrebbe pure un suo fascino, nei termini del messaggio che vuol mandare, della tesi di cui vuol persuadere.
Siamo abituati a pensare al denaro – alla sua logica calcolatrice, razionale e ottimizzante – come a un meccanismo implacabile e inarrestabile.
Di quando in quando – non molto spesso, però succede – questo meccanismo si inceppa, gira a vuoto, e noi con lui, incapaci di immaginare soluzioni alternative, di pensare e agire diversamente da come il denaro ci costringe a pensare e agire.
I tre fratelli saranno condannati a un moto perpetuo di telefonate reciproche, se non romperanno il giocattolo, se non distruggeranno il meccanismo, se non introdurranno un criterio meta-economico nella ripartizione dell’eredità, che oltrepassi la logica individualistica del denaro.
“Chi pensa di ottenere di più, senza assicurarsi spazi di manovra diversi dal denaro, finisce stritolato da quello stesso meccanismo che si illude di governare”.
Siamo abituati a pensare al denaro – alla sua logica calcolatrice, razionale e ottimizzante – come a un meccanismo implacabile e inarrestabile.
Di quando in quando – non molto spesso, però succede – questo meccanismo si inceppa, gira a vuoto, e noi con lui, incapaci di immaginare soluzioni alternative, di pensare e agire diversamente da come il denaro ci costringe a pensare e agire.
I tre fratelli saranno condannati a un moto perpetuo di telefonate reciproche, se non romperanno il giocattolo, se non distruggeranno il meccanismo, se non introdurranno un criterio meta-economico nella ripartizione dell’eredità, che oltrepassi la logica individualistica del denaro.
“Chi pensa di ottenere di più, senza assicurarsi spazi di manovra diversi dal denaro, finisce stritolato da quello stesso meccanismo che si illude di governare”.
E questo potrebbe essere il messaggio del racconto, la tesi “dimostrata” dalla storia (dove le virgolette segnalano il senso tecnico da attribuire alla dimostrazione: ciò di cui l’autore voleva persuadere il lettore).
Tutto molto bello, ma noi qui parliamo di tecnica e stile di scrittura, e c’è allora da chiedersi quanto possa andare avanti una buona idea prima di crollare sotto il peso di uno stile insostenibile, tenuto conto della fragilità del mondo in cui la storia si svolge.
Tutto molto bello, ma noi qui parliamo di tecnica e stile di scrittura, e c’è allora da chiedersi quanto possa andare avanti una buona idea prima di crollare sotto il peso di uno stile insostenibile, tenuto conto della fragilità del mondo in cui la storia si svolge.
La storia sarà pure graziosa, ma sconta una narrazione manifestamente esterna: abbiamo la chiara sensazione che qualcuno ci sta raccontando qualcosa, di essere considerati come bambini da intrattenere con una favola, solo che noi non siamo bambini – en passant: la narrativa per bambini è un mondo a parte – e non vogliamo sentirci raccontare niente da nessuno, ma semplicemente vivere la vita del personaggio come fosse la nostra.
La narrazione esterna – oltre a suonare di per sé infantile, indipendentemente dal soggetto e della trama – produce quasi naturalmente interruzioni, parentesi, incisi – tutte cose che impareremo a chiamare col loro nome: infodump – cosicché la storia vera e propria, più che raccontata, è intravista a malapena tra una foschia di frasi.
Prendiamo ad esempio questo passaggio.
Luca era esterrefatto. Proprio non se lo aspettava, non da Stefano. Li divideva poco più di un anno di età, erano cresciuti come gemelli, avevano un legame forte, un rapporto esclusivo, a cui Valeria, arrivata cinque anni dopo, non era mai riuscita a prender parte, vuoi per la differenza anagrafica vuoi perché femmina. E ora lui, proprio lui, il suo gemello putativo, lo tradiva così?
Non ha chiaramente nessuna attinenza stretta con la narrazione, con ciò che sta accadendo “qui e ora” nel mondo della pagina. Stefano, Luca e Valeria sono perfettamente consapevoli di quale sia il loro passato, sanno benissimo come si è svolta la loro vita sino a quel momento, e non hanno nessun motivo, “qui e ora”, di richiamare alla memoria eventi e situazioni a loro ben note.
Ma il lettore invece non sa nulla dei tre, e così la storia viene a tutti gli effetti “messa in pausa” per fornire, dall’esterno, quelle informazioni senza le quali sarebbe problematico continuare a seguirla. Se fossimo a teatro, è come se gli attori all’improvviso si bloccassero, e il regista salisse sul palco per spiegare al pubblico il passato tormentato dei tre fratelli, per poi tornare dietro le quinte con tante scuse. “Perdonate davvero la pausa e l’intrusione, ma se non vi dicevo queste cose, poi rischiavate di non capirci nulla. Scusate ancora, e buon proseguimento con lo spettacolo”.
Ti sembrerebbe una soluzione artistica accettabile, se fossimo a teatro? No, ovviamente. Perché distruggerebbe l’illusione di realtà. Con ogni probabilità ti alzeresti per andar via, nel timore che il regista possa riapparire di nuovo per dare altre spiegazioni, e poi ancora e ancora, perché una volta che si è presa l’abitudine a intromettersi nella storia, è difficile farne a meno.
E infatti il regista ricompare a ogni piè sospinto, timoroso che gli spettatori si possano smarrire all’interno di una disposizione testamentaria così singolare.
Non aveva forse stabilito così il padre? Almeno due su tre dovevano essere d'accordo. Eccoli qui: Stefano e Luca, due su tre.
Non aveva forse stabilito così il padre? Almeno due su tre dovevano essere d'accordo. Eccoli qui: Stefano e Luca, due su tre.
Non
aveva forse detto così il padre? Due su tre dovevano essere d'accordo.
Eccoli qui: non più Stefano e Luca, ma Stefano e Valeria, non più metà e
metà, ma due terzi e un terzo, però sempre due su tre erano, ed erano
d'accordo, e tanto bastava a rispettare la volontà del padre.
Non aveva forse detto così il padre? Due su tre dovevano essere d'accordo. Eccoli qui: Luca e Valeria.
Ma – si dirà – il teatro è il teatro, la scrittura è la scrittura, sono due media diversi, perciò ci sta che una soluzione inaccettabile in un ambito possa invece essere una prassi nell’altro.
Si e no.
Si e no.
Sì, è vero che teatro e scrittura sono media diversi, e quindi soggiacciono a logiche di costruzione e a modalità attuative diverse.
No, se questa diversità viene invocata per giustificare scelte stilistiche subottimali, per rendere accettabile ciò che non lo è, per fare male, spacciandolo per fatto bene, ciò che si può realmente fare bene, decisamente meglio.
E qui si può far meglio da molti punti di vista: dalla focalizzazione su un singolo personaggio – uno tra Valeria, Stefano e Luca – che eviti di sballottare il lettore tra punti di vista in contrasto (moduli 18A e 18B), all’eliminazione dei discorsi indiretti – le sintesi dei dialoghi, a cura dello scrittore – che impediscono al lettore di sentire le esatte parole pronunciate dai personaggi (modulo 12), all’attenzione a non spiattellare gli stati d’animo con le etichette – “Luca era esterrefatto” – ma comunicarli attraverso le azioni, le percezioni, i dialoghi, i pensieri (moduli 9 e 10).
Non preoccuparti se ora non capisci del tutto il senso di queste osservazioni. Ogni cosa ti sarà chiara al terzo giro completo del manuale. Garantito.
Per ora è sufficiente aver realizzato l’ambivalenza del mondo della pagina, il suo essere potente e fragile allo stesso tempo: è potente, perché quando sfruttato a dovere crea un coinvolgimento emotivo virtualmente impossibile da riscontare altrove; è fragile, perché basta un nulla a far sì che si riveli per quel che è, un ammasso di segni grafici scritti su un foglio o su una schermata.














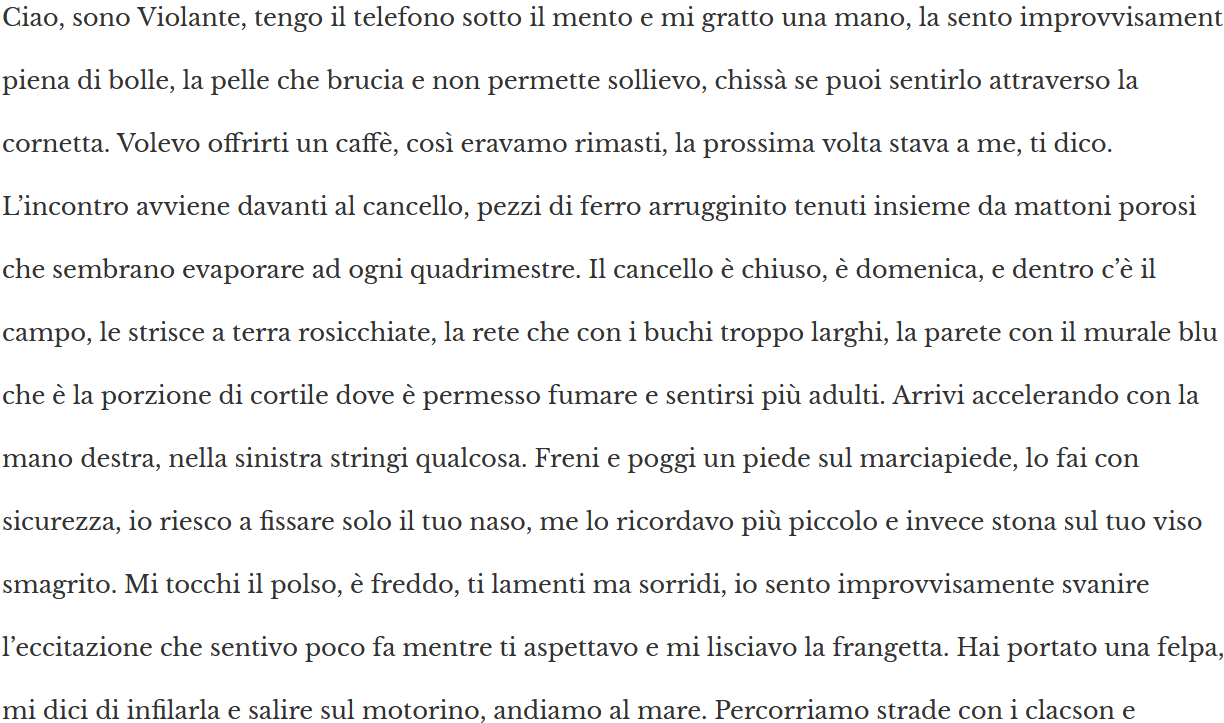





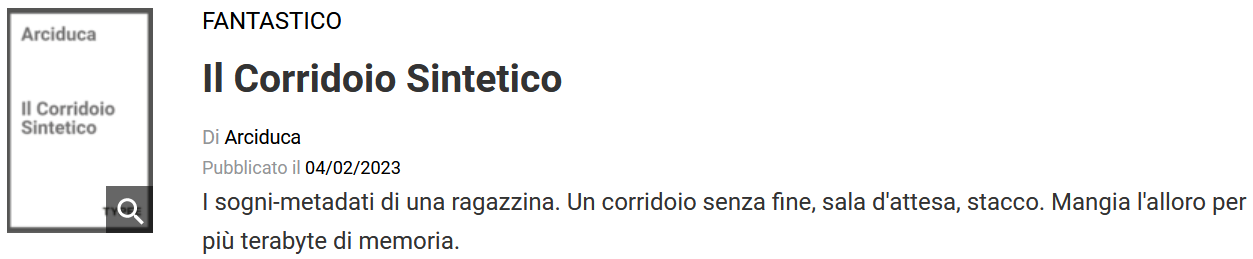









Commenti
Posta un commento